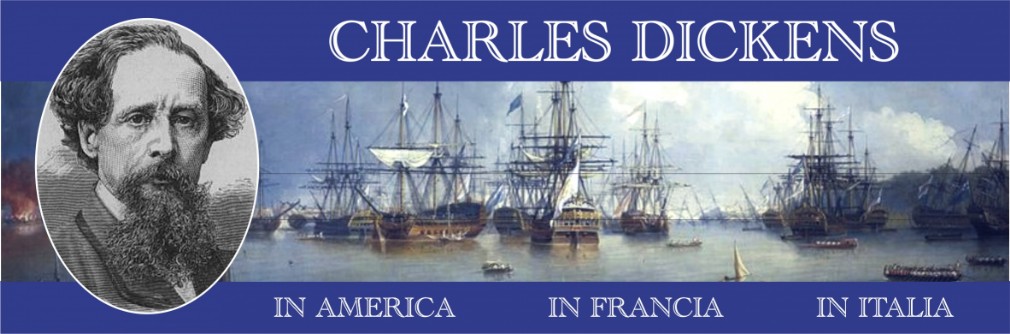Quel mattino del 7 giugno, che ho atteso così a lungo, il mio interesse per la forza e la direzione del vento era più vivo che mai. Un giorno o due prima un esperto mi aveva detto che qualunque vento sarebbe andato bene, purché provenisse da ovest. Così, quando, all’alba, ho spalancato la finestra e sono stato accarezzato da una brezza vivace nata nella notte e proveniente da nord ovest, ho cominciato ad avere una considerazione particolare per i venti che spirano da quel quadrante della bussola. E credo che continuerò a tenerli in gran conto fino a quando avrò esalato il mio ultimo soffio, perché saranno legati al ricordo.
Il nostro pilota non aveva perso tempo nel mettere a frutto il vento favorevole, e la nave, fino a ieri ormeggiata in mezzo a un groviglio di imbarcazioni che sembravano renderne impossibile la partenza, stava adesso a sedici miglia al largo. Con le sue alberature alte ed eleganti, che facevano risaltare contro il cielo i pennoni e i cordami, essa costituiva una vista splendida mentre ci avvicinavamo con il rimorchiatore. E ci è apparsa ancora più superba quando siamo saliti a bordo e, fra vigorosi cori di Evviva!, è stata tirata su l’ancora e la nave ha cominciato ad avanzare nella scia del rimorchiatore. E’ sembrata magnifica anche quando è stata sciolto il cavo di traino e le vele guizzanti si sono spalancate come grandi ali bianche, mentre la nave si slanciava nel suo viaggio libero e solitario.
Nella cabina di poppa eravamo solo quindici passeggeri. La prima notte è stata dura e burrascosa, lo stesso i due giorni successivi, che però sono passati in fretta e non hanno cambiato l’umore del gruppo. Sotto la guida del bravo e coraggioso capitano, tutti si erano ripromessi di essere vicendevolmente gradevoli.
 Facevamo la prima colazione alle otto, la seconda colazione a mezzogiorno e il pranzo alle tre. Alle sette e mezza bevevamo il tè. C’erano molti passatempi, a cominciare dal pranzo stesso, che, a causa dei lunghi intervalli fra le varie portate, non durava mai meno di due ore e mezzo, cosa che di per sé metteva allegria. Per ingannare il tedio di questi banchetti, si era formato, all’estremità inferiore della tavola, un gruppo di persone al cui distinto presidente non faccio allusioni per modestia. Era un’associazione allegra e gioviale, vista con simpatia dal resto dei passeggeri, e in particolare da un cameriere nero, che non smetteva di sorridere alle battute di spirito di quei rispettabili signori.
Facevamo la prima colazione alle otto, la seconda colazione a mezzogiorno e il pranzo alle tre. Alle sette e mezza bevevamo il tè. C’erano molti passatempi, a cominciare dal pranzo stesso, che, a causa dei lunghi intervalli fra le varie portate, non durava mai meno di due ore e mezzo, cosa che di per sé metteva allegria. Per ingannare il tedio di questi banchetti, si era formato, all’estremità inferiore della tavola, un gruppo di persone al cui distinto presidente non faccio allusioni per modestia. Era un’associazione allegra e gioviale, vista con simpatia dal resto dei passeggeri, e in particolare da un cameriere nero, che non smetteva di sorridere alle battute di spirito di quei rispettabili signori. Si poteva giocare a scacchi e a whist, a cribbage, a backgammon e a shovelboard. E poi c’erano libri. Ma noi eravamo sempre sul ponte, con qualsiasi tempo. Passeggiavamo a due a due, ci sdraiavamo nelle scialuppe, ci sporgevamo oltre il parapetto o chiacchieravamo in pigri gruppetti. Non mancava la musica. Dalle sei del mattino, un passeggero suonava la fisarmonica, un altro il violino, un terzo il cornetto a pistone. L’effetto combinato dei pezzi diversi suonati con grande convinzione in luoghi vicini e a portata d’orecchio era orrendo in modo sublime.
In mancanza di altre distrazioni, una vela apparsa all’orizzonte, nella nebbiosa lontananza, ci sembrava il fantasma di una nave. Altre volte, con i binocoli, distinguevamo il nome e la direzione di un’imbarcazione che ci passava accanto e vedevamo anche la gente sul ponte. Guardavamo per ore i delfini e le focene che saltavano e si tuffavano intorno alla nave oppure le piccole procellarie, sempre in volo vicino a poppa, che ci hanno tenuto compagnia per almeno quindici giorni dopo la partenza da New York.
Per qualche giorno abbiamo avuto bonaccia e un vento assai debole. L’equipaggio si divertiva a pescare e ha tirato su uno sventurato delfino dai colori variegati, che è venuto a morire sul ponte. Nella successione monotona delle nostre giornate questo evento ha avuto una grande importanza e ha segnato l’inizio di una nuova era, con un nuovo calendario.
 Dopo cinque o sei giorni si è cominciato a parlare di iceberg. I passeggeri delle navi che erano entrate nel porto di New York pochi giorni prima della nostra partenza ne avevano visto un gran numero. Ad avvertire della presenza pericolosa di queste isole erranti era il clima diventato improvvisamente rigido e l’abbassamento del barometro. Sono stati organizzati dei doppi turni di guardia e, la sera, si raccontavano tristi storie di navi urtate e affondate nel buio. Per fortuna il vento ci ha spinti verso sud, dove il tempo era caldo e luminoso, e così non ne abbiamo visto nemmeno uno.
Dopo cinque o sei giorni si è cominciato a parlare di iceberg. I passeggeri delle navi che erano entrate nel porto di New York pochi giorni prima della nostra partenza ne avevano visto un gran numero. Ad avvertire della presenza pericolosa di queste isole erranti era il clima diventato improvvisamente rigido e l’abbassamento del barometro. Sono stati organizzati dei doppi turni di guardia e, la sera, si raccontavano tristi storie di navi urtate e affondate nel buio. Per fortuna il vento ci ha spinti verso sud, dove il tempo era caldo e luminoso, e così non ne abbiamo visto nemmeno uno. Il rilevamento di mezzogiorno e la successiva correzione di rotta erano un momento di somma importanza per noi. Non mancavano – non succede mai - i passeggeri che dubitavano dei calcoli del capitano e che, appena questi voltava le spalle, si mettevano a prendere le misure sulla carta nautica con un pezzetto di spago, con l’estremità di un fazzoletto o con lo spegnitoio, dimostrando che si era sbagliato di qualche migliaio di miglia. Era istruttivo vedere questi increduli scuotere la testa e aggrottare le ciglia, ascoltare le loro dissertazioni sulla scienza della navigazione, di cui peraltro non sapevano nulla. Tuttavia il loro umore era più variabile del mercurio del termometro. Quando la nave solcava veloce le onde erano pronti a giurare che il nostro comandante era il migliore del mondo, degno di una targa d’onore, ma quando la brezza calava e le vele pendevano inutili nell’aria immobile, scuotevano la testa. A labbra serrate, dicevano di sperare che il comandante sapesse il fatto suo, cosa di cui dubitavano.
Una delle nostre occupazioni nei giorni di bonaccia era diventata quella di chiederci, curiosi, quando sarebbe venuto fuori il vento dal punto giusto. Secondo le carte e i casi precedenti, il fenomeno avrebbe già dovuto succedere da tempo. Il nostromo sembrava chiamarlo, soffiando nel suo fischietto e riscuotendo così anche il rispetto degli increduli, che lo consideravano un marinaio di prima classe. Durante il pranzo, noi gettavamo occhiate tristi alle vele, attraverso i vetri. Qualcuno, reso ardito dalla disperazione, prediceva che, di quel passo, non saremmo sbarcati prima di luglio. A bordo delle navi ci sono sempre i pessimisti e gli ottimisti.  Quel giorno, trionfavano i pessimisti che, a ogni pasto, chiedevano ai vicini dove pensavano che fosse in quel momento il piroscafo Great Western, partito da New York una settimana dopo di noi, e dove fosse arrivato il postale Cunard e che cosa pensassero dei velieri rispetto ai piroscafi. Per tranquillità e per amor di pace, gli ottimisti rintuzzavano gli attacchi dimostrando a loro volta un certo pessimismo.
Quel giorno, trionfavano i pessimisti che, a ogni pasto, chiedevano ai vicini dove pensavano che fosse in quel momento il piroscafo Great Western, partito da New York una settimana dopo di noi, e dove fosse arrivato il postale Cunard e che cosa pensassero dei velieri rispetto ai piroscafi. Per tranquillità e per amor di pace, gli ottimisti rintuzzavano gli attacchi dimostrando a loro volta un certo pessimismo.
 Quel giorno, trionfavano i pessimisti che, a ogni pasto, chiedevano ai vicini dove pensavano che fosse in quel momento il piroscafo Great Western, partito da New York una settimana dopo di noi, e dove fosse arrivato il postale Cunard e che cosa pensassero dei velieri rispetto ai piroscafi. Per tranquillità e per amor di pace, gli ottimisti rintuzzavano gli attacchi dimostrando a loro volta un certo pessimismo.
Quel giorno, trionfavano i pessimisti che, a ogni pasto, chiedevano ai vicini dove pensavano che fosse in quel momento il piroscafo Great Western, partito da New York una settimana dopo di noi, e dove fosse arrivato il postale Cunard e che cosa pensassero dei velieri rispetto ai piroscafi. Per tranquillità e per amor di pace, gli ottimisti rintuzzavano gli attacchi dimostrando a loro volta un certo pessimismo. A bordo c’era un altro motivo d’interesse. Sul ponte di terza classe, un centinaio di passeggeri formava un piccolo mondo di povertà. Guardandoli mentre passeggiavano, cucinavano e mangiavano, siamo giunti a conoscerne di vista qualcuno e avevamo la curiosità di conoscere anche la loro storia. Volevamo sapere con quali speranze erano partiti per l’America e a causa di quali circostanze adesso se ne tornavano a casa. Dal carpentiere, che aveva la responsabilità di badare a loro, abbiamo avuto delle informazioni curiose. Alcuni di essi si erano fermati in America solo tre giorni, altri si erano fermati tre mesi, altri ancora avevano fatto il viaggio di andata sulla stessa nave con cui adesso tornavano a casa. C’era chi aveva venduto gli abiti per comprarsi il biglietto ed era coperto di stracci e chi non aveva nulla da mangiare viveva di quel poco che gli davano i compagni. All’arrivo si è scoperto che un uomo era vissuto delle ossa e dei pezzetti di grasso rimasti sui piatti messi via per essere lavati.
Bisogna riformare il sistema di trasporto di queste persone sfortunate. Se c’è una categoria che ha bisogno di essere aiutata è proprio questa, obbligata a lasciare la propria terra per poter sopravvivere. Il comandante e gli ufficiali, spinti da umanità e compassione, fanno di tutto per quei poveretti, ma c’è bisogno di molto di più. La legge deve impedire il loro ammassamento sulle navi, deve garantire che le sistemazioni siano dignitose e non avvilenti, senza promiscuità. Nessuno deve poter salire a bordo senza che un ufficiale ne controlli le provviste, che devono essere sufficienti per il viaggio. Le malattie degli adulti e le morti di bambini sono frequenti, quindi ci deve essere un’assistenza medica che oggi non c’è. Inoltre, è dovere del governo, monarchico o repubblicano che sia, intervenire presso le agenzie di viaggio che noleggiano i locali e li stipano di emigranti. Il numero di cuccette, a differenza di adesso, deve essere adeguato e gli uomini e le donne devono viaggiare separati, con un minimo di comfort. Il profitto immediato delle imprese non può essere l’unico criterio. E la cosa peggiore è che molti agenti, per aumentare il proprio profitto, allettano quei disgraziati con promesse irrealizzabili e li trascinano verso un avvenire ancora più pieno di miseria.
Le famiglie a bordo avevano più o meno la stessa storia. Dopo aver risparmiato o preso in prestito i soldi o venduto tutto per pagare il biglietto, erano arrivati a New York pensando di trovare le strade della città coperte d’oro. Invece, le avevano trovate coperte di pietre molto dure. L’iniziativa era scarsa, non c’era bisogno nuove braccia e il lavoro che si trovava non era retribuito. Perciò se ne tornavano a casa più poveri di quando erano partiti. Uno di loro aveva con sé la lettera di un giovane artigiano arrivato a New York quindici giorni prima e indirizzata a un amico: “Questo sì che è un bel posto, Jim! L’America mi piace perché non c’è dispotismo, che è già una gran cosa. Qui si trova ogni tipo di lavoro, i salari sono buoni e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Io non ho ancora deciso se fare il carpentiere o il sarto, ma deciderò presto.”
Durante la bonaccia, le nostre conversazioni avevano come argomento uno dei passeggeri, un marinaio inglese di navi da guerra, sveglio e preciso, che si era arruolato nella flotta americana. Stava tornando a casa per una licenza, a rivedere gli amici. Essendo un bravo marinaio, quando era andato a fare il biglietto gli era stato offerto un passaggio gratis in cambio del suo lavoro sulla nave, ma lui aveva rifiutato, dicendo: “Che io sia dannato se, almeno questa volta, non faccio questo viaggio da gentiluomo!”. Ma, appena salito a bordo, ha portato il suo bagaglio negli alloggi dei marinai e si è mescolato agli uomini dell’equipaggio. E, appena ce n’é stato bisogno, è salito come un gatto su per i cordami e per i pennoni, pronto a dare una mano con sobria dignità e con un sorriso modesto. “Lo faccio per divertimento, come un gentiluomo!” diceva.
Quando finalmente è arrivato il vento, siamo filati a vele spiegate, solcando in modo superbo le acque. C’era qualcosa di grandioso nel movimento della nave, messa in ombra dalla massa delle vele, che avanzava furiosa sull’acqua e ci colmava di orgoglio esultante. Mi piaceva guardare le verdi onde avventarsi sulla nave con i loro bordi bianchi, per sollevarla e avvolgerla quando lei si abbassava, ma per riconoscerla poi come loro padrona! Volavamo nella luce cangiante di una zona benedetta, con il sole brillante di giorno e la luna splendente di notte. La banderuola puntava dritto verso casa e rappresentava un segnale veritiero per il vento favorevole e per i nostri cuori allegri. Poi, all’alba di lunedì 27 giugno - una data che non dimenticherò mai - è apparso Cape Clear, come una nuvola luminosa e gradita, la più auspicabile fra quelle che hanno sorvolato casa nostra, sorella terrestre del paradiso. Era un punto appena visibile all’orizzonte, ma per merito suo l’aurora era diventata più allegra, con un caldo interesse che di solito manca negli spazi marini. Sul mare, il ritorno del giorno è inseparabile da un sentimento di gioia e di speranza, ma la luce che brilla sulla distesa d’acqua desolata ne rivela anche l’immensa solitudine. Tuttavia, è uno spettacolo più solenne della notte che avvolge tutto nelle sue tenebre indefinite. Solo il sorgere della luna, pur con la sua aria di nobile malinconia, sembra confortare col il suo tocco morbido e gentile l’oceano solitario, a cui si addice. Quand’ero bambino immaginavo che il riflesso della luna sull’acqua fosse un sentiero verso il Paradiso, percorso dalle anime delle persone buone in viaggio verso Dio, una fantasia che mi tornava in mente mentre osservavo la notte calma sul mare.
Quel lunedì mattina il vento era debole ma nella giusta direzione. A poco a poco abbiamo lasciato dietro di noi Cape Clear e abbiamo fatto rotta verso le coste irlandesi. Si può immaginare quanto fossimo allegri e quante congratulazioni ci siamo scambiate. Fiduciosi, abbiamo tirato a indovinare l’ora del nostro arrivo a Liverpool. A pranzo abbiamo brindato alla salute del comandante, poi siamo andati con furia a preparare i bagagli. Due o tre passeggeri rifiutavano di andare a letto non giudicando ne valesse la pena con l’arrivo tanto vicino, ma alla fine ci sono andati e hanno dormito profondamente. Essere così vicini alla meta sembrava un sogno piacevole da cui si temeva di essere svegliati.
 Il giorno dopo il vento amico è aumentato e noi abbiamo ripreso a fuggirgli davanti. Ogni tanto sfrecciavamo davanti a una nave inglese che viaggiava verso il porto a velatura ridotta. Verso sera, il tempo è peggiorato e la pioggerella era così fitta che sembrava di navigare in una nube. Ma continuavamo ad avanzare come un vascello fantasma e lanciavamo occhiate al marinaio di guardia, in attesa di Holyhead.
Il giorno dopo il vento amico è aumentato e noi abbiamo ripreso a fuggirgli davanti. Ogni tanto sfrecciavamo davanti a una nave inglese che viaggiava verso il porto a velatura ridotta. Verso sera, il tempo è peggiorato e la pioggerella era così fitta che sembrava di navigare in una nube. Ma continuavamo ad avanzare come un vascello fantasma e lanciavamo occhiate al marinaio di guardia, in attesa di Holyhead. Nel momento in cui abbiamo udito il grido tanto atteso, davanti a noi è apparsa una vivida luce, che è subito scomparsa per riapparire un momento dopo. I passeggeri stavano immobili con gli occhi fissi sul fascio luminoso del faro che rotava sulla roccia di Holyhead. Tutti ne apprezzavano lo splendore e l’avvertimento amichevole e ne lodavano i pregi, superiori a quelli di ogni altro faro, fino a quando, dopo un ultimo guizzo, la luce è scomparsa.
Il fumo del colpo di cannone si era appena dileguato quando è apparso un battello piccolo e veloce, con una lanterna sulla punta dell’albero maestro, che veniva verso di noi. Il suo pilota è salito a bordo ed è rimasto con noi sulle tavole del ponte. Era completamente coperto e imbacuccato, per proteggersi dal freddo. Se ci avesse chiesto in prestito cinquanta sterline, senza garanzie e senza scadenza, gliele avremmo date immediatamente, prima che il suo battello ripartisse e prima di aver letto le notizie sul giornale che ci aveva portato.
Quella sera ci siamo coricati molto tardi e la mattina dopo ci siamo alzati presto. Alle sei eravamo tutti sul ponte, intenti a guardare le guglie, i tetti e il fumo di Liverpool, pronti a sbarcare. Alle otto mangiavamo il nostro ultimo pasto tutti insieme al ristorante di un hotel. Alle nove ci siamo stretti la mano e abbiamo sciolto il gruppo.
La campagna che si vedeva dal treno sembrava uno splendido giardino, di cui ci era ben nota la bellezza dei piccoli campi, delle siepi, degli alberi, delle villette, delle aiuole, delle vecchie chiese e delle case. In una sola giornata erano condensate le gioie degli anni a venire, quelle del ritorno alle cose che ci rendono cara la patria e che né la mia lingua né la mia penna potrebbero descrivere.