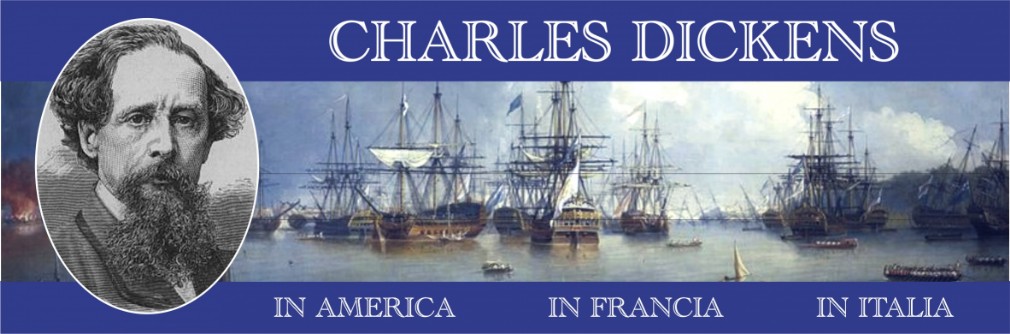Dovevamo effettuare la prima parte del viaggio in battello e, dato che si partiva alle quattro del mattino, si passava la notte a bordo. Per questo motivo, proprio quando si apprezzerebbe di più un paio di pantofole e un letto familiare, abbiamo dovuto scendere al molo dove era ormeggiato il battello.
Sono le dieci di sera, forse le dieci e trenta: c’è il chiaro di luna, fa abbastanza caldo e c’è foschia. Il battello, simile a un’arca di Noè per bambini, con le macchine sul tetto, si muove pigramente su e giù, andando a sbattere pesantemente contro la palizzata del molo, mentre le increspature del fiume giocano con la sua vecchia carcassa scombiccherata. Il molo è a una certa distanza dalla città. Non c’è nessuno in giro dopo che la carrozza se n’è andata, una debole lampada o due sul ponte del battello sono gli unici segni di vita. Appena i nostri passi risuonano sulle assi, una negra grassa, che madre natura ha fornito di un voluminoso posteriore, emerge da una scala buia e accompagna mia moglie alla cabina delle signore, dove ella si ritira, seguita da un’imponente sacco di cappotti e soprabiti pesanti. Io decido coraggiosamente di non andare a dormire e di passare la notte a passeggiare su e giù lungo il molo.
Comincio la mia passeggiata – pensando a ogni sorta di persone e cose lontane e a niente di vicino – per mezz’ora. Poi salgo di nuovo a bordo e guardo l’ora alla luce di una delle lampade, ma deve essersi fermato. Mi chiedo cosa stia facendo il fedele segretario che mi sono portato dietro da Boston. Sta cenando con il nostro ex padrone di casa - senza dubbio è come minimo Maresciallo - per celebrare la nostra partenza e ne avrà almeno per altre due ore. Ricomincio a camminare, ma diventa sempre più scuro, la luna tramonta e, con questo buio, giugno mi sembra lontanissimo; l’eco dei miei passi mi rende nervoso. E poi fa freddo e camminare su e giù senza compagnia in un luogo così solitario è un ben misero divertimento. Così break la mia ferma decisione precedente e penso che, dopotutto, è forse meglio andare a letto.
Salgo di nuovo a bordo; apro la porta della cabina per uomini ed entro. Forse perché è così silenziosa, mi sembra che non ci sia nessuno. Con orrore e incredulità mi accorgo che è piena di gente addormentata in ogni foggia e disposizione: nelle cuccette, sulle sedie, sul pavimento, sulle tavole e particolarmente attorno alla stufa, la mia odiata nemica. Faccio un passo e sbatto contro la faccia lustra di uno inserviente nero, che è disteso sul pavimento avvolto in una coperta. Salta su, fa una smorfia simile a un sorriso un po’ per cortesia un po’ per il dolore, mi bisbiglia il mio nome all’orecchio e, a tentoni fra le persone immerse nel sonno, mi guida verso la mia cuccetta. Stando in piedi accanto ad essa conto i dormienti. Quando arrivo a contarne quaranta, decido di non andare oltre e comincio a spogliarmi. Poiché le sedie sono tutte occupate, metto i miei vestiti per terra, sporcandomi le mani, perché il pavimento è nelle stesse condizioni dei tappeti del Campidoglio e per la stessa ragione. Dopo essermi spogliato solo parzialmente, mi arrampico sul mio ripiano e per qualche minuto tengo la tenda scostata, mentre do un’altra occhiata ai miei compagni di viaggio. Dopo di che, la richiudo su di loro e sul mondo, mi giro e mi addormento.
 Appena entriamo sotto pressione mi sveglio per il rumore. Spunta l’alba e tutti si svegliano nello stesso momento. Alcuni riacquistano subito la lucidità, altri hanno l’aria di domandarsi, perplessi, dove siano, si stropicciano gli occhi e si guardano intorno appoggiati su di un gomito. Alcuni sbadigliano, altri si lamentano, quasi tutti sputano, pochi decidono di alzarsi. Io sono fra questi, dato che, anche senza uscire fuori all’aria fresca, è facile sentire che l’aria nella cabina è malsana al massimo grado. Io mi infagotto in fretta nei vestiti, scendo nella cabina di prua, mi faccio fare la barba, mi lavo.
Appena entriamo sotto pressione mi sveglio per il rumore. Spunta l’alba e tutti si svegliano nello stesso momento. Alcuni riacquistano subito la lucidità, altri hanno l’aria di domandarsi, perplessi, dove siano, si stropicciano gli occhi e si guardano intorno appoggiati su di un gomito. Alcuni sbadigliano, altri si lamentano, quasi tutti sputano, pochi decidono di alzarsi. Io sono fra questi, dato che, anche senza uscire fuori all’aria fresca, è facile sentire che l’aria nella cabina è malsana al massimo grado. Io mi infagotto in fretta nei vestiti, scendo nella cabina di prua, mi faccio fare la barba, mi lavo.ll necessario da toeletta per i passeggeri consiste di due asciugamani a rullo, tre piccole bacinelle di legno, un barilotto d’acqua e un mestolo per attingerla, sei pollici quadrati di specchio, altrettanto di sapone giallo, un pettine e una spazzola per i capelli e nulla per i denti. Tutti usano la spazzola, ad eccezione di me, e tutti mi fissano perché uso i miei. Due o tre gentiluomini sembrano sul punto di irridermi per i miei pregiudizi, ma non lo fanno. Dopo la toeletta, salgo sul ponte di passeggiata e dò inizio a un paio d’ore di camminata veloce su e giù. Il sole sorge luminoso, stiamo oltrepassando Mount Vernon, dove è sepolto Washington; il fiume è largo e rapido, le sue sponde sono belle. Il giorno arriva in tutto il suo splendore e la sua gloria e diventa a ogni istante più brillante.
Alle otto, facciamo colazione nella cabina, dove ho passato la notte, ma le finestre ora sono spalancate ed è abbastanza fresco. Apparentemente, non c’è fretta né ingordigia nel mangiare. La colazione prende più tempo che da noi, c’è più ordine ed educazione.
 Subito dopo le nove, arriviamo a Potomac Creek, dove dobbiamo sbarcare e qui comincia la parte più strana del viaggio. Sette diligenze si stanno preparando ad accoglierci. Alcune sono già pronte, altre no. Alcuni cocchieri sono neri, altri bianchi. Ogni vettura ha quattro cavalli, che, bardati o no, sono già tutti sul posto. I passeggeri escono dal battello ed entrano nelle carrozze; il bagaglio è trasportato su carretti rumorosi; i cavalli sono spaventati e impazienti di partire; i vetturini neri parlano loro, come tante scimmie, quelli bianchi incalzandoli con grida come tanti bovari: perché la cosa più importante per gli stallieri è fare più rumore possibile. Le carrozze somigliano a quelle francesi, ma non sono altrettanto comode, perché invece delle molle di sospensione hanno delle strisce di cuoio solidissimo. Non c’è molta differenza fra l’una e l’altra e si possono paragonare alle altalene a forma di vetturette in uso nelle fiere inglesi, che sono sistemate su ruote unite da tronchi, coperte da un tetto e con le finestrelle chiuse da tendine dipinte. Sono coperte di fango dal tetto ai cerchioni delle ruote e non sono mai state lavate dal giorno della costruzione.
Subito dopo le nove, arriviamo a Potomac Creek, dove dobbiamo sbarcare e qui comincia la parte più strana del viaggio. Sette diligenze si stanno preparando ad accoglierci. Alcune sono già pronte, altre no. Alcuni cocchieri sono neri, altri bianchi. Ogni vettura ha quattro cavalli, che, bardati o no, sono già tutti sul posto. I passeggeri escono dal battello ed entrano nelle carrozze; il bagaglio è trasportato su carretti rumorosi; i cavalli sono spaventati e impazienti di partire; i vetturini neri parlano loro, come tante scimmie, quelli bianchi incalzandoli con grida come tanti bovari: perché la cosa più importante per gli stallieri è fare più rumore possibile. Le carrozze somigliano a quelle francesi, ma non sono altrettanto comode, perché invece delle molle di sospensione hanno delle strisce di cuoio solidissimo. Non c’è molta differenza fra l’una e l’altra e si possono paragonare alle altalene a forma di vetturette in uso nelle fiere inglesi, che sono sistemate su ruote unite da tronchi, coperte da un tetto e con le finestrelle chiuse da tendine dipinte. Sono coperte di fango dal tetto ai cerchioni delle ruote e non sono mai state lavate dal giorno della costruzione. I biglietti che ci hanno dato sul battello recano stampato il numero 1, quindi il nostro posto è nella carrozza numero 1. Getto il cappotto sull’imperiale e aiuto mia moglie e la cameriera a issarsi all’interno. C’è solo un gradino e, poiché è posto a una iarda da terra, di solito si usa una sedia per salirvi; quando la sedia non c’è, le signore si affidano alla Provvidenza. La carrozza porta nove persone, dato che fra le due porte - dove noi inglesi mettiamo le gambe - viene sistemata una panca. In questo modo, c’è una sola cosa che risulti più difficile che entrare: uscire. All’esterno, a cassetta, c’è posto per un solo passeggero. Poiché quel passeggero sono io, mi arrampico su, mentre legano i bagagli sul tetto e li ammucchiano in una specie di portabagagli posteriore.
 Per il primo mezzo miglio di strada si passa su ponti fatti di assi appoggiate trasversalmente su due pali paralleli, che sobbalzano quando le ruote vi passano sopra. Poi si entra nel fiume, che ha un fondo argilloso e pieno di buche, nelle quali i cavalli spariscono all’improvviso e dove se ne perdono le tracce per un po’.
Per il primo mezzo miglio di strada si passa su ponti fatti di assi appoggiate trasversalmente su due pali paralleli, che sobbalzano quando le ruote vi passano sopra. Poi si entra nel fiume, che ha un fondo argilloso e pieno di buche, nelle quali i cavalli spariscono all’improvviso e dove se ne perdono le tracce per un po’. Ma anche questo passa e arriviamo alla strada vera e propria, costituita da una serie di pantani e di buche sabbiose. Un punto pericoloso ci attende a poca distanza: il vetturino nero rotea gli occhi, arrotonda le labbra e guarda dritto fra i due cavalli di testa con l’aria di dire: “Siamo passati spesso di qui, ma questa volta credo che avremo un incidente.” Prende le redini a due mani, le tira forte, mentre fa ballare i piedi sul predellino (pur continuando a restare seduto), come faceva il povero Ducrow quando montava due dei suoi impetuosi corsieri. Arriviamo nel punto critico, affondiamo nel fango fino ai finestrini, ci pieghiamo da un lato formando un angolo di quarantacinque gradi e restiamo piantati là. Dall’interno si levano grida disperate; la carrozza è ferma; i cavalli si dibattono nel fango; anche le altre sei carrozze si fermano e i loro ventiquattro cavalli si dimenano allo stesso modo, per sostenere i nostri e per simpatia verso di loro.
Poi i cavalli si arrampicano di corsa sul pendio ai lati della strada e ridiscendono a velocità spaventosa. E’ impossibile fermarli e al fondo c’è una buca profonda, piena d’acqua. La carrozza sobbalza in modo spaventoso. All’interno tutti urlano. Il fango e l’acqua schizzano da tutte le parti. Il vetturino nero balla come un invasato. All’improvviso, non si sa come, tutto è a posto e ci fermiamo per riprendere fiato.
In due ore e mezza abbiamo percorso circa dieci miglia, senza ossa rotte, ma con molte ammaccature. In breve, coprendo la distanza “come una freccia”.

Questo viaggio singolare termina a Fredericksburg, da dove c’è un treno per Richmond. Il tratto di paese che attraversa era un tempo una campagna fertile, ma il terreno si è esaurito per il sistema di impiegare un gran numero di schiavi a forzare i raccolti, senza rinvigorire la terra. Oggi essa è poco più che un deserto sabbioso ricoperto di alberi. Per quanto desolato e monotono fosse il suo aspetto, sono stato felice di vedervi una maledizione causata da quell’odiosa istituzione che è la schiavitù e ho provato più piacere a contemplare quella terra disseccata che se al suo posto ci fossero state coltivazioni ubertose.
Siamo arrivati all’hotel fra le sei e le sette di sera. Davanti ad esso, in cima a un’ampia scalinata che portava all’ingresso, due o tre cittadini fumavano il sigaro mentre si dondolavano sulle sedie. Abbiamo trovato l’hotel spazioso ed elegante e siamo stati trattati tanto bene quanto un viaggiatore possa desiderarlo. Il clima caldo faceva venir sete e a ogni ora del giorno il grande bar non era mai a corto di clienti e la mescita di cocktail freschi non cessava mai; ma qui la gente sembrava più allegra e gli strumenti musicali, che era un piacere ascoltare, suonavano tutta la notte.
 Il giorno seguente e quello dopo ancora abbiamo percorso a piedi e in carrozza la città, che sorge su otto colline a strapiombo sul fiume James; un corso d’acqua scintillante, disseminato qua e là di luminosi isolotti e di rumorose cascatelle. Benché fossimo solo a metà marzo, in questo clima meridionale la temperatura era caldissima; i peschi e le magnolie erano in piena fioritura e tutte le piante erano verdi.
Il giorno seguente e quello dopo ancora abbiamo percorso a piedi e in carrozza la città, che sorge su otto colline a strapiombo sul fiume James; un corso d’acqua scintillante, disseminato qua e là di luminosi isolotti e di rumorose cascatelle. Benché fossimo solo a metà marzo, in questo clima meridionale la temperatura era caldissima; i peschi e le magnolie erano in piena fioritura e tutte le piante erano verdi. In una vallata fra le colline c’è una spianata conosciuta come il Bloody Run (Valle del Sangue) per il terribile conflitto con gli Indiani avvenuto qui. E’ un posto ideale per un simile combattimento e, come ogni altro luogo associato con le leggende di questo popolo selvaggio destinato a scomparire presto dalla faccia della terra, mi interessava molto.
La città è sede del Parlamento della Virginia e nelle sue ombrose aule legislative alcuni oratori sproloquiavano con tono sonnolento sul caldo di mezzogiorno. A causa delle continue ripetizioni, quelle visioni costituzionali non mi interessavano ormai più di qualche consiglio parrocchiale ed ero lieto di far cambio con una visita a una biblioteca pubblica contenente circa diecimila volumi e di andare in una manifattura di tabacchi, i cui lavoratori erano tutti schiavi.
 Era mia intenzione procedere dal fiume James e dalla baia di Chesapeake fino a Baltimora; ma poiché uno dei battelli era mancato all’appuntamento a causa di un guasto e poiché i collegamenti erano di conseguenza molto incerti, siamo tornati a Washington per la strada da cui eravamo venuti (sul battello c’erano due poliziotti alla ricerca di schiavi fuggitivi) e dopo esserci fermati là per una notte, abbiamo proseguito per Baltimora il pomeriggio seguente.
Era mia intenzione procedere dal fiume James e dalla baia di Chesapeake fino a Baltimora; ma poiché uno dei battelli era mancato all’appuntamento a causa di un guasto e poiché i collegamenti erano di conseguenza molto incerti, siamo tornati a Washington per la strada da cui eravamo venuti (sul battello c’erano due poliziotti alla ricerca di schiavi fuggitivi) e dopo esserci fermati là per una notte, abbiamo proseguito per Baltimora il pomeriggio seguente. In questa città c’è il più confortevole di tutti gli hotel, e non sono pochi, di cui ho fatto esperienza negli Stati Uniti: il Barnum’s. Per la prima, e probabilmente ultima volta in America il viaggiatore inglese trova il letto provvisto di tende e, con tutta probabilità, acqua sufficiente per la propria toeletta, cosa tutt’altro che comune.
 La capitale dello stato del Maryland è una città animata e indaffarata, con diverse imprese commerciali, in particolare di trasporto fluviale e marittimo. Il quartiere dove hanno sede le loro fiorenti attività non è dei più puliti, ma i quartieri residenziali, posti in alto, sono di natura completamente diversa e contano numerose vie ed edifici pubblici molto gradevoli. Ci sono il monumento a George Washington, una colonna imponente sormontata da una statua del presidente, la Facoltà di Medicina e il monumento della Battaglia, che ricorda lo scontro con i Britannici a North Point.
La capitale dello stato del Maryland è una città animata e indaffarata, con diverse imprese commerciali, in particolare di trasporto fluviale e marittimo. Il quartiere dove hanno sede le loro fiorenti attività non è dei più puliti, ma i quartieri residenziali, posti in alto, sono di natura completamente diversa e contano numerose vie ed edifici pubblici molto gradevoli. Ci sono il monumento a George Washington, una colonna imponente sormontata da una statua del presidente, la Facoltà di Medicina e il monumento della Battaglia, che ricorda lo scontro con i Britannici a North Point. Dopo un giorno o due di permanenza ho deciso di attenermi strettamente al programma che avevo predisposto, intraprendendo senza ulteriore ritardo il viaggio verso ovest. Di conseguenza, dopo aver spedito a New York i bagagli di cui non avevamo strettamente bisogno, essermi procurato le lettere credenziali per le banche poste sul nostro itinerario, aver contemplato per due sere di seguito il tramonto del sole con un’idea del paese che ci attendeva tanto precisa quanto avrebbe potuto esserlo se avessimo fatto un viaggio al centro della terra abbiamo preso il treno delle otto e mezza del mattino e siamo arrivati a York, lontana circa sessanta miglia, giusto in tempo per cenare all’hotel davanti al quale partiva la diligenza a quattro cavalli diretta ad Harrisburg. La vettura venuta a prenderci alla stazione, sulla quale ho avuto la fortuna di trovare un posto, era buia e fangosa come al solito.
All’inizio il paesaggio era abbastanza privo di interesse, poi, nelle ultime dieci o dodici miglia, è diventato molto bello. La strada serpeggiava attraverso la piacevole valle di Susquehanna. Alla nostra destra scorreva il fiume, disseminato di innumerevoli isole verdeggianti, a sinistra si ergeva una ripida collinetta coperta di pini e di rocce contorte. Scivolando solennemente sull’acqua, la bruma componeva mille forme fantastiche, e la penombra della sera dava a ogni cosa un’aria di mistero e di silenzio che ne ravvivava grandemente l’interesse naturale.
Il ponte che abbiamo attraversato era di legno, coperto da un tetto e chiuso ai lati da due alte pareti, di circa un miglio di lunghezza. La struttura era formata da grandi travi che si incrociavano più volte secondo tutti gli angoli possibili e attraverso i buchi e le aperture si poteva vedere l’acqua giù in basso brillare come miriadi di occhi. Non avevamo lanterne, i cavalli procedevano inciampando e barcollando verso una debole luce lontana e sembrava che il percorso non dovesse mai finire.
Avanzavamo pesantemente, facendo risuonare il ponte di rumori cavernosi e, mentre tenevo la testa abbassata per evitare le travi, non riuscivo a persuadermi che non fosse un brutto sogno. Mi è capitato sovente di sognare di attraversare posti simili e mi dicevo che, anche questa volta, “non poteva essere reale.”
Malgrado tutto, alla fine siamo sbucati nelle strade di Harrisburg, le cui luci scialbe, riflesse dal suolo bagnato, non rischiaravano una città molto allegra. Ci siamo sistemati in un hotel confortevole, più piccolo e meno lussuoso di altri in cui siamo scesi, ma che nel mio ricordo li sorpassava tutti per via del suo direttore, l’uomo più cortese, educato e premuroso che mi sia mai capitato di incontrare.
Essendo la partenza fissata per il pomeriggio, l’indomani mattina sono uscito dopo colazione per andare a perlustrare i dintorni. Mi sono stati mostrati una prigione modello appena terminata, basata sul sistema dell’isolamento, che non annoverava ancora detenuti, il tronco di un albero molto vecchio a cui degli Indiani ostili avevano saldamente legato il primo colono, di nome Harris, salvato dalla tempestiva apparizione di un partito amico sull’altra riva del fiume, la legislazione locale e altre curiosità della città.
 Ho esaminato con grande interesse una serie di trattati stipulati con gli sfortunati Indiani, firmati dai diversi capi e conservati negli uffici del guardasigilli. Le firme consistevano in rozzi disegni degli animali o delle armi di cui essi portavano il nome: Grossa Tartaruga ha disegnato con un tratto di penna esitante la sagoma di questo animale, Bisonte ha raffigurato un bisonte, Ascia di Guerra ha apposto come marchio la rappresentazione sommaria di quest’arma. Lo stesso hanno fatto Freccia, Pesce, Scalpo, Grande Piroga e tutti gli altri.
Ho esaminato con grande interesse una serie di trattati stipulati con gli sfortunati Indiani, firmati dai diversi capi e conservati negli uffici del guardasigilli. Le firme consistevano in rozzi disegni degli animali o delle armi di cui essi portavano il nome: Grossa Tartaruga ha disegnato con un tratto di penna esitante la sagoma di questo animale, Bisonte ha raffigurato un bisonte, Ascia di Guerra ha apposto come marchio la rappresentazione sommaria di quest’arma. Lo stesso hanno fatto Freccia, Pesce, Scalpo, Grande Piroga e tutti gli altri. Davanti a queste riproduzioni esitanti e tremanti, eseguite da mani che erano in grado di armare la freccia più lunga su di un arco ricavato da un corno di alce, di dividere in due una pietra o una piuma con una palla di fucile, mi veniva fatto di pensare ai sogni di Crabbe ne Il Registro parrocchiale e ai tratti di penna irregolari lasciati da uomini capaci di tracciare un solco perfettamente rettilineo con l’aratro. Non ho potuto impedirmi di nutrire pensieri tristi su questi guerrieri semplici, la cui scrittura e il cui cuore stavano là, in tutta verità e sincerità, che, con il tempo, avevano imparato dagli uomini bianchi a venir meno alla parola data e a cavillare sulla forma e sul merito dei trattati. Mi domando quante volte il credulo Grossa Tartaruga o il fiducioso Piccola Ascia abbiano apposto la loro firma su trattati di cui non era stato rivelato loro il tenore e abbiano sottoscritto cose che non conoscevano, fino al giorno in cui finivano per scatenarsi sui nuovi possessori della terra. Davvero dei selvaggi.
Prima di pranzo il nostro ospite ci ha annunciato che alcuni membri del corpo legislativo avevano l’intenzione di farci l’onore di una visita e per questo ci aveva cortesemente messo a disposizione il piccolo boudoir della sua sposa. Quando l’ho pregato di farli entrare, l’ho visto guardare il grazioso tappeto con un’aria di dolorosa apprensione, ma in quel momento avevo la mente altrove e mi è sfuggito il motivo della sua preoccupazione.
Ma sarebbe stato ben più gradevole se questi signori, senza compromettere la loro indipendenza, non solo avessero ceduto al pregiudizio favorevole alle sputacchiere ma si fossero anche affidati all’assurdità convenzionale del fazzoletto da tasca.
Continuava a piovere abbondantemente e, quando siamo scesi al battello fluviale - il nostro nuovo mezzo di trasporto - il tempo era poco allettante e ostinatamente umido. La vista dell’imbarcazione su cui avremmo trascorso tre o quattro giorni, non era in alcun modo incoraggiante e ha fatto nascere in noi qualche preoccupata supposizione riguardo al modo in cui i passeggeri sarebbero stati alloggiati per la notte, dando origine a un largo ventaglio di interrogativi sulle altre sistemazioni domestiche dei locali interni, che apparivano abbastanza sconcertanti.
L’ aspetto esterno era quello di una chiatta con una piccola casa sopra, mentre dentro essa sembrava la roulotte di un luna park. I signori erano sistemati come gli spettatori dei musei sulle ruote, dove vengono rivelati dei prodigi per un penny. Le signore erano separate da una tenda rossa, come lo sono in quei luoghi i giganti e i nani, per proteggerne in qualche modo la vita privata.
Ci siamo seduti, osservando in silenzio le due file di piccoli tavoli ai lati della cabina, ascoltando lo sgocciolio e il picchiettio della pioggia e lo sciabordio dell’acqua attorno al battello fino all’arrivo del treno, il cui contributo al numero dei nostri passeggeri era l’unico motivo che ci aveva trattenuti dal partire. I nuovi bagagli venivano scaraventati sul tetto della cabina con tale violenza da darci l’impressione di riceverli sulla testa senza la protezione di un copricapo da facchino.  Molti passeggeri nuovi erano bagnati fino alle ossa e quando si sono messi attorno alla stufa, i loro vestiti hanno cominciato a fumare. Senza dubbio l’ambiente sarebbe stato più confortevole se la pioggia battente, che in quel momento cadeva più insistente che mai, avesse permesso di aprire una finestra o se il numero di passeggeri non fosse salito a trenta. Ma non abbiamo avuto il tempo di abbandonarci a queste considerazioni perché stavano attaccando i tre cavalli da alaggio alla gomena. Il ragazzo che cavalcava l’animale di testa ha fatto schioccare la frusta e il timone ha cominciato a gemere e a cigolare. Avevamo cominciato il viaggio.
Molti passeggeri nuovi erano bagnati fino alle ossa e quando si sono messi attorno alla stufa, i loro vestiti hanno cominciato a fumare. Senza dubbio l’ambiente sarebbe stato più confortevole se la pioggia battente, che in quel momento cadeva più insistente che mai, avesse permesso di aprire una finestra o se il numero di passeggeri non fosse salito a trenta. Ma non abbiamo avuto il tempo di abbandonarci a queste considerazioni perché stavano attaccando i tre cavalli da alaggio alla gomena. Il ragazzo che cavalcava l’animale di testa ha fatto schioccare la frusta e il timone ha cominciato a gemere e a cigolare. Avevamo cominciato il viaggio.
 Molti passeggeri nuovi erano bagnati fino alle ossa e quando si sono messi attorno alla stufa, i loro vestiti hanno cominciato a fumare. Senza dubbio l’ambiente sarebbe stato più confortevole se la pioggia battente, che in quel momento cadeva più insistente che mai, avesse permesso di aprire una finestra o se il numero di passeggeri non fosse salito a trenta. Ma non abbiamo avuto il tempo di abbandonarci a queste considerazioni perché stavano attaccando i tre cavalli da alaggio alla gomena. Il ragazzo che cavalcava l’animale di testa ha fatto schioccare la frusta e il timone ha cominciato a gemere e a cigolare. Avevamo cominciato il viaggio.
Molti passeggeri nuovi erano bagnati fino alle ossa e quando si sono messi attorno alla stufa, i loro vestiti hanno cominciato a fumare. Senza dubbio l’ambiente sarebbe stato più confortevole se la pioggia battente, che in quel momento cadeva più insistente che mai, avesse permesso di aprire una finestra o se il numero di passeggeri non fosse salito a trenta. Ma non abbiamo avuto il tempo di abbandonarci a queste considerazioni perché stavano attaccando i tre cavalli da alaggio alla gomena. Il ragazzo che cavalcava l’animale di testa ha fatto schioccare la frusta e il timone ha cominciato a gemere e a cigolare. Avevamo cominciato il viaggio.Poiché la pioggia continuava a cadere persistentemente, sono rimasti tutti sotto coperta. I signori con i vestiti bagnati, ammassati attorno al fornello, ammuffivano a poco a poco, sotto l’effetto del calore. Gli altri erano allungati sulle panche, dormivano di un sonno inquieto con la faccia sul tavolo o camminavano su e giù per la cabina con il rischio, se erano anche solo di statura media, di consumarsi la calotta cranica contro il basso soffitto. Verso le sei sono stati uniti i tavoli per formarne uno solo e tutti si sono accomodati a consumare tè, caffè, pane, burro, salmone, alosa, fegato, bistecche, patate, sottaceti, prosciutto, braciole, sanguinacci e salsicce.
Il pasto è stato divorato con voracità e gli uomini si infilavano in gola le larghe lame dei coltelli e le forchette a due denti più di quanto avessi mai visto fare in precedenza, se non da un illusionista. Tuttavia, nessuno si è seduto prima delle signore o è venuto meno al più piccolo gesto di cortesia che potesse contribuire a dare loro piacere. E nel corso dei miei spostamenti in America non ho visto alcuna donna fatta segno del più piccolo atto di villania o d’inciviltà e nemmeno di disattenzione.
Alla fine del pasto, la pioggia, che sembrava essersi esaurita negli scrosci impetuosi e abbondanti, era quasi cessata, rendendo possibile salire sul ponte. Benché questo fosse molto piccolo e lo spazio fosse reso ancora più esiguo dai bagagli che, ammucchiati al centro sotto a un telone, lasciavano solo una stretta passerella ai lati, lo stare fuori era un grande sollievo, anche se era una scienza andare da un’estremità all’altra senza capitombolare oltre il bordo e cadere nel canale. All’inizio, trovavamo un po’ fastidioso chinarci in fretta ogni cinque minuti, quando l’uomo al timone gridava: “Ponte!”, o allungarci quasi con il ventre a terra al grido di “Ponte basso!”, ma la pratica abitua a tutto e i ponti erano talmente numerosi che ci siamo abituati in poco tempo.
 Scendeva la notte quando siamo giunti in vista della prima fila di colline che formano i contrafforti dei monti Alleghany. Il paesaggio, che fin ad allora era stato senza interesse, è diventato più nitido e attraente. Dopo la pioggia abbondante, la terra odorava ed esalava fumo e vapore leggero e il gracidio delle rane, che in queste regioni fanno un baccano incredibile, ci faceva pensare di essere accompagnati da milioni di fate che agitavano campanellini e che si muovevano nell’aria alla nostra altezza. Il cielo notturno era percorso da nuvole, ma a tratti c’era anche la luna. Quando abbiamo superato il fiume Susquehanna, valicato da uno straordinario ponte di legno con due gallerie sovrapposte, che consentivano a due treni diretti in senso contrario, di incrociarsi senza difficoltà, il paesaggio è diventato selvaggio e grandioso.
Scendeva la notte quando siamo giunti in vista della prima fila di colline che formano i contrafforti dei monti Alleghany. Il paesaggio, che fin ad allora era stato senza interesse, è diventato più nitido e attraente. Dopo la pioggia abbondante, la terra odorava ed esalava fumo e vapore leggero e il gracidio delle rane, che in queste regioni fanno un baccano incredibile, ci faceva pensare di essere accompagnati da milioni di fate che agitavano campanellini e che si muovevano nell’aria alla nostra altezza. Il cielo notturno era percorso da nuvole, ma a tratti c’era anche la luna. Quando abbiamo superato il fiume Susquehanna, valicato da uno straordinario ponte di legno con due gallerie sovrapposte, che consentivano a due treni diretti in senso contrario, di incrociarsi senza difficoltà, il paesaggio è diventato selvaggio e grandioso. Ho già accennato ai miei dubbi sul modo in cui venivano sistemati i passeggeri per dormire. Sono rimasto nell’incertezza fino alle 11, quando sono sceso sottocoperta e ho visto tre lunghe file di scaffali da libreria appesi ai due lati della cabina, adatti a volumi di formato in ottavo piccolo. Osservando più attentamente quelle suppellettili, meravigliato di trovare un tale corredo letterario in un posto simile, ho scoperto che su ogni scaffale c’erano delle microscopiche lenzuola e coperte. Allora ho cominciato indistintamente/vagamente a capire che il contenuto della libreria era costituito dai passeggeri., che vi si disponevano sopra di taglio e non si muovevano più fino al mattino.
Ciò che mi ha aiutato a giungere a questa conclusione è stata la vista di alcuni di loro che, riuniti attorno al capitano, tiravano a sorte i numeri della lotteria con l’ansia e la passione del giocatore dipinta sul viso. Altri, con un pezzo di carta in mano, cercavano a tentoni il numero corrispondente a quello estratto. Appena lo avevano individuato, si spogliavano immediatamente e vi strisciavano dentro. La rapidità con cui essi passavano dal ruolo di giocatori angosciati a quello di dormienti che russavano sonoramente è uno degli effetti più singolari che abbia mai visto.
Quanto alle signore, esse erano già a letto, dietro a una tenda rossa, che era stata accuratamente tirata e tenuta chiusa al centro con uno spillo; ma i colpi di tosse, gli starnuti, i bisbigli perfettamente udibili ci rendevano consapevole della loro presenza.
La gentilezza del capitano mi aveva procurato un posto vicino alla tenda rossa, un po’ defilato rispetto al grosso dei dormienti. Mi sono ritirato dopo aver ringraziato molto il comandante per la sua premura. Ho misurato la mia cuccetta e ho trovato che non era più grande di un foglio di carta da lettere di Bath. Non sapevo bene come fare per entrarci, ma poiché era in basso, ho deciso di sdraiarmi sul pavimento, di scivolare dentro lentamente fino a fermarmi quando ho toccato il materasso. Sono rimasto coricato sullo stesso fianco per il resto della notte. Fortunatamente,ci sono riuscito. Ma quando ho alzato gli occhi mi sono spaventato a vedere che la sagoma dell’occupante di sopra debordava di un buon mezzo metro e si poteva dedurre che il suo peso rendeva difficile il compito delle sottili corde che lo dovevano sorreggere. Non ho potuto fare a meno di pensare al dolore di mia moglie e di tutta la famiglia nel caso lui fosse caduto giù durante la notte, ma dato che non potevo rialzarmi senza una vera e propria lotta che avrebbe allarmato le signore, e inoltre non avevo alcun altro luogo dove andare, ho chiuso gli occhi davanti al pericolo e mi sono addormentato.
Ci sono due tipi di persone che viaggiano su battelli come questo. Gli irrequieti, che spingono la loro irrequietezza a tal punto da non dormire mai e quelli che continuano a espettorare anche quando dormono e sognano, mischiando così il reale all’irreale. Finché abbiamo navigato sul canale, ogni notte c’era una tempesta di sputi che durava fino al risveglio; una volta il mio cappotto si è trovato al centro di un uragano alimentato da cinque gentiluomini, che si muoveva/procedeva in modo verticale, secondo la legge di Reid sugli uragani, e io sono stato costretto ad allargarlo sul ponte, a spazzolarlo e spruzzarlo con acqua prima di poterlo nuovamente indossare.
Ci alzavamo fra le 5 e le 6 per permettere di smontare gli scaffali, poi alcuni di noi andavano sul ponte, altri si affollavano attorno alla stufa appena accesa perché faceva molto freddo. Qui essi continuavano a prodursi nell’attività notturna e facevano piovere sulla griglia il loro generoso contributo. Le comodità per lavarsi erano molto primitive. C’era una secchia di ferro legata sul ponte con la quale chiunque volesse lavarsi (alcuni erano superiori a questa debolezza) tirava su l’acqua sporca del canale e la versava in una catinella, anch’essa assicurata al battello. Per asciugarsi, c’era un asciugamano che girava su un rullo. Davanti a uno specchio del bar, accanto al pane, al formaggio e ai biscotti, c’erano un pettine e una spazzola a disposizione di tutti.
Alle otto, dopo aver tolto le cuccette e riunito i tavoli, ognuno si trovava davanti tè, caffè, pane, burro, salmone, alosa, fegato, bistecche, patate, sottaceti, prosciutto, alosa, braciole di maiale, sanguinaccio, salsicce. Ad alcuni piaceva mescolare tutte le pietanze e le mettevano insieme nel piatto. E quando le razioni di tè, caffè, pane, burro,…. erano finite e le briciole erano state spazzate via, è riapparso uno dei camerieri nelle vesti di barbiere e ha fatto la barba a chi lo desiderava, mentre gli altri guardavano o sbadigliavano dietro il giornale. Il pranzo era una ripetizione della prima colazione senza il tè e il caffè mentre la cena ne era una copia esatta.
 Il canale naturalmente finiva ai piedi della montagna e i passeggeri venivano trasportati in diligenza dall’altra parte, dove li attendeva un altro battello, simile al primo. Vi erano due linee di battelli: l’Express e il Pioneer, più economico. Il Pioneer è arrivato per primo alle montagne e ha atteso i passeggeri dell’Express, dato che i due gruppi dovevano passare insieme attraverso il valico. Noi eravamo sull’Express e quando abbiamo superato la montagna e raggiunto l’altro battello, i proprietari della compagnia si sono messi in testa di imbarcare sul nostro anche i passeggeri del Pioneer, con il risultato che a bordo eravamo almeno quarantacinque persone. L’aumento del numero dei passeggeri non ha contribuito a migliorare le condizioni del viaggio, soprattutto per la notte. Quelli che viaggiavano con noi hanno brontolato, come si fa in casi simili, ma hanno permesso che il battello partisse, seppure così carico. In patria avrei protestato vigorosamente, ma qui sono uno straniero e sono rimasto zitto.
Il canale naturalmente finiva ai piedi della montagna e i passeggeri venivano trasportati in diligenza dall’altra parte, dove li attendeva un altro battello, simile al primo. Vi erano due linee di battelli: l’Express e il Pioneer, più economico. Il Pioneer è arrivato per primo alle montagne e ha atteso i passeggeri dell’Express, dato che i due gruppi dovevano passare insieme attraverso il valico. Noi eravamo sull’Express e quando abbiamo superato la montagna e raggiunto l’altro battello, i proprietari della compagnia si sono messi in testa di imbarcare sul nostro anche i passeggeri del Pioneer, con il risultato che a bordo eravamo almeno quarantacinque persone. L’aumento del numero dei passeggeri non ha contribuito a migliorare le condizioni del viaggio, soprattutto per la notte. Quelli che viaggiavano con noi hanno brontolato, come si fa in casi simili, ma hanno permesso che il battello partisse, seppure così carico. In patria avrei protestato vigorosamente, ma qui sono uno straniero e sono rimasto zitto. La prima colazione era il pasto meno appetitoso della giornata, perché, in aggiunta ai numerosi e gustosi profumi dei cibi, arrivavano dal piccolo bar vicino gli odori del gin, del whisky, dell’acquavite e del rum, fortemente conditi dal tanfo di tabacco stantio. Molti passeggeri non erano molto scrupolosi riguardo alla propria biancheria intima, che a volte era gialla come i piccoli rivoli di saliva essiccata che avevano agli angoli della bocca. L’atmosfera non era esente da un leggero zefiro che proveniva dai trenta letti appena disfatti, la cui presenza era rammentata dall’occasionale comparsa sulla tovaglia da una varietà di selvaggina che non figurava nel menu).
Tuttavia, ricordo con grande piacere questo strano modo di viaggiare che, almeno ai miei occhi, aveva un suo lato umoristico e fra le molte cose che apprezzavo c’era lo schizzare fuori dall’aria viziata della cabina alle cinque del mattino, senza il colletto della camicia, per avventurarmi sul ponte sporco, attingere dell’acqua ghiacciata, immergervi la faccia e tirarla fuori fresca e arrossata per il freddo; il giretto rapido, compiuto sull’alzaia, fra la toeletta e la colazione, in cui ogni vena e ogni arteria pulsavano di salute; la squisita bellezza dell’alba, quando da ogni cosa sembrava emanare una luce; il pigro abbrivio del battello mentre si era distesi sul ponte a contemplare l’azzurro del cielo nel quale sembrava di essere immersi; lo scivolare silenziosamente in mezzo ai versanti minacciosi delle colline, resi più scuri dagli alberi, turbati a volte da una piccola macchia rossa là in alto, dove uomini invisibili si stringevano intorno a un fuoco; lo scintillio vivo degli astri, non disturbato da rumori di ruote o di macchine, all’infuori del gorgoglio limpido dell’acqua mentre il battello avanzava. Tutte queste erano pure delizie.
 Si vedevano dei nuovi edifici, e, qua e là, delle capanne di tronchi d’abete, piene d’interesse per degli stranieri provenienti da una vecchia nazione. Le baracche di legno erano provviste, all’esterno, di rudimentali forni di argilla. Si vedevano porcili decorosi quasi quanto le case, vetri rotti tappati con dei cappelli consunti, vestiti vecchi, panche tarlate, frammenti di coperte e pezzi di carta, credenze artigianali costruite senza porte, nelle quali erano riposti poche pentole e recipienti di terracotta. L’occhio era addolorato nel vedere i grossi ceppi d’albero ammassati nei campi di grano e, più raramente, le eterne paludi e i tetri pantani con centinaia di tronchi marci dai rami contorti immersi nelle loro acque malsane. Era triste e opprimente attraversare le distese di terra dove i coloni avevano bruciato gli alberi, i cui corpi feriti giacevano intorno come creature assassinate. Qua e là qualche gigante carbonizzato tendeva in alto due bracci rinsecchiti e sembrava gettare una maledizione sui propri nemici.
Si vedevano dei nuovi edifici, e, qua e là, delle capanne di tronchi d’abete, piene d’interesse per degli stranieri provenienti da una vecchia nazione. Le baracche di legno erano provviste, all’esterno, di rudimentali forni di argilla. Si vedevano porcili decorosi quasi quanto le case, vetri rotti tappati con dei cappelli consunti, vestiti vecchi, panche tarlate, frammenti di coperte e pezzi di carta, credenze artigianali costruite senza porte, nelle quali erano riposti poche pentole e recipienti di terracotta. L’occhio era addolorato nel vedere i grossi ceppi d’albero ammassati nei campi di grano e, più raramente, le eterne paludi e i tetri pantani con centinaia di tronchi marci dai rami contorti immersi nelle loro acque malsane. Era triste e opprimente attraversare le distese di terra dove i coloni avevano bruciato gli alberi, i cui corpi feriti giacevano intorno come creature assassinate. Qua e là qualche gigante carbonizzato tendeva in alto due bracci rinsecchiti e sembrava gettare una maledizione sui propri nemici. Di tanto in tanto, il canale serpeggiava attraverso a una gola solitaria, simile a un valico fra le montagne scozzesi, che di notte riluceva di un luccichio gelido sotto la luna. Le ripide pareti non sembravano avere altro sbocco che il passaggio da cui eravamo venuti, ma la collinetta accidentata si apriva di colpo, nascondendo il chiaro di luna e, man mano che ci addentravamo nella sua lugubre gola, la nostra nuova strada veniva avvolta da tenebre e ombre.
 Avevamo lasciato Harrisburg il venerdì e la domenica mattina siamo arrivati ai piedi delle montagne, da superare in ferrovia. C’erano dieci piani inclinati, cinque per l’ascensione e cinque per la discesa, sui quali le vetture venivano alzate e poi abbassate con l’aiuto di macchine fisse. Gli spazi relativamente orizzontali che separavano i piani venivano superati con l’aiuto dei cavalli o della locomotiva, secondo i casi. In alcuni tratti, i binari erano posati sul bordo di un precipizio vertiginoso e lo sguardo del viaggiatore spaziava nelle profondità della montagna, senza siepi o barriere di rocce davanti. Il trasporto avveniva con prudenza e precauzione, i convogli erano composti da due sole vetture e non c’era da temere alcun pericolo.
Avevamo lasciato Harrisburg il venerdì e la domenica mattina siamo arrivati ai piedi delle montagne, da superare in ferrovia. C’erano dieci piani inclinati, cinque per l’ascensione e cinque per la discesa, sui quali le vetture venivano alzate e poi abbassate con l’aiuto di macchine fisse. Gli spazi relativamente orizzontali che separavano i piani venivano superati con l’aiuto dei cavalli o della locomotiva, secondo i casi. In alcuni tratti, i binari erano posati sul bordo di un precipizio vertiginoso e lo sguardo del viaggiatore spaziava nelle profondità della montagna, senza siepi o barriere di rocce davanti. Il trasporto avveniva con prudenza e precauzione, i convogli erano composti da due sole vetture e non c’era da temere alcun pericolo. Era affascinante viaggiare ad andatura sostenuta in mezzo alle cime delle montagne, con un vento vivace, e contemplare una vallata piena di luce e di dolcezza, osservando le capanne visibili fra le cime degli alberi. Alcuni bambini correvano fino alla porta di casa, da cui schizzavano fuori dei cani che abbaiavano senza che potessimo sentirli; dei maiali spaventati scappavano via verso il loro rifugio; delle famiglie erano sedute nel giardino incolto; delle mucche alzavano lo sguardo indifferente e stupido; degli uomini in maniche di camicia osservavano la loro casa in costruzione progettando il lavoro dell’indomani. E noi passavamo alti sopra di loro, come un turbine.
Era affascinante viaggiare ad andatura sostenuta in mezzo alle cime delle montagne, con un vento vivace, e contemplare una vallata piena di luce e di dolcezza, osservando le capanne visibili fra le cime degli alberi. Alcuni bambini correvano fino alla porta di casa, da cui schizzavano fuori dei cani che abbaiavano senza che potessimo sentirli; dei maiali spaventati scappavano via verso il loro rifugio; delle famiglie erano sedute nel giardino incolto; delle mucche alzavano lo sguardo indifferente e stupido; degli uomini in maniche di camicia osservavano la loro casa in costruzione progettando il lavoro dell’indomani. E noi passavamo alti sopra di loro, come un turbine. E’ stato divertente scendere sferragliando per una gola scoscesa, mossi solo dal peso delle vetture, e vedere la locomotiva andare giù per la china da sola, ronzando come un grosso insetto, con il dorso verde e oro luccicante sotto il sole. Nessuno di noi sarebbe rimasto sorpreso se essa avesse spiegato le ali e preso il volo. Invece, si è fermata tempestivamente nel momento in cui raggiungevamo il canale, per poi ripartire ansimando su per la salita, prima ancora che noi avessimo lasciato il pontile, con i passeggeri che avevano atteso il nostro arrivo per andare in direzione contraria alla nostra.
Nella serata di lunedì, i fuochi di fornace e i colpi di martello sulle rive del canale annunciavano che ci stavamo avvicinando alla fine di questa parte del nostro viaggio. Dopo aver attraversato un altro posto di sogno, più singolare ancora del ponte di Harrisburg – un acquedotto formato da una vasta camera di legno sopra il fiume Alleghany - siamo sbucati in mezzo a un orribile groviglio di parti posteriori di edifici, di gallerie e di scale bizzarre, come ce ne sono ai bordi dei fiumi, dei canali, dei fossati e del mare: eravamo arrivati a Pittsburg.
 Pittsburg somiglia a Birmingham, in Inghilterra. Per lo meno questo è quello che affermano i suoi abitanti. E a parte le strade, i negozi, le case, i carri, le fabbriche, gli edifici pubblici, la popolazione, forse potrebbe esserlo. La città è coperta da una grande quantità di fumo ed è famosa per le sue ferriere. Oltre alla prigione, conta un arsenale ben concepito e diverse istituzioni. Essa è magnificamente situata sul fiume Alleghany, valicato da due ponti. Le ville dei cittadini più ricchi, di cui sono disseminate le alture circostanti, sono abbastanza graziose. Siamo scesi in un hotel eccellente, dove siamo stati serviti mirabilmente. Il posto, di grandi dimensioni e con un ampio colonnato a ogni piano, era gremito, come sempre.
Pittsburg somiglia a Birmingham, in Inghilterra. Per lo meno questo è quello che affermano i suoi abitanti. E a parte le strade, i negozi, le case, i carri, le fabbriche, gli edifici pubblici, la popolazione, forse potrebbe esserlo. La città è coperta da una grande quantità di fumo ed è famosa per le sue ferriere. Oltre alla prigione, conta un arsenale ben concepito e diverse istituzioni. Essa è magnificamente situata sul fiume Alleghany, valicato da due ponti. Le ville dei cittadini più ricchi, di cui sono disseminate le alture circostanti, sono abbastanza graziose. Siamo scesi in un hotel eccellente, dove siamo stati serviti mirabilmente. Il posto, di grandi dimensioni e con un ampio colonnato a ogni piano, era gremito, come sempre. Siamo rimasti tre giorni. La tappa successiva era Cincinnati, da raggiungere in battello a vapore. Queste imbarcazioni dell’Ovest hanno la tendenza a esplodere con la frequenza di una o due la settimana, perciò era prudente raccogliere indicazioni sulla sicurezza delle navi che facevano scalo sul fiume. Ci è stato caldamente raccomandato il Messenger, di cui si annunciava la partenza da una quindicina di giorni, ma che non era mai partito. Lo stesso comandante non sembrava avere un’idea precisa sull’argomento. Ma dove andrebbe a finire la libertà personale se la legge obbligasse un cittadino libero e indipendente a mantenere la parola data nei confronti del pubblico? Così vanno gli affari e, se dei passeggeri si vedono ingannati, chi dirà: “Bisogna porre un termine a tutto questo”, essendo egli stesso un uomo d’affari?
Non conoscendo le abitudini locali, e impressionato dall’accento di profonda solennità dell’annuncio della partenza, mi sono precipitato a bordo, dove sono arrivato senza fiato. Mi è stato poi detto, in via confidenziale, che il battello non sarebbe partito prima di venerdì 1 aprile. Perciò abbiamo atteso quel giorno molto confortevolmente e siamo saliti a bordo a mezzogiorno.
Visto dal piazzale sopraelevato, che costituiva il punto d’approdo, e sullo sfondo della riva opposta del fiume, il Messenger non era che uno dei tanti battelli ad alta pressione raggruppati vicino al pontile e non sembrava di tonnellaggio superiore ad altri che erano in acqua. Aveva una quarantina di passeggeri a bordo, senza contare le persone più povere imbarcate sul ponte inferiore. Il disormeggio ha avuto luogo in meno di mezz’ora.
Ci è stata assegnata una cameretta con due cuccette, accanto alla cabina delle signore. La sistemazione era a poppa, dove ci era stato raccomandato di stare, visto che quei battelli avevano la tendenza a esplodere a prua. Era una cautela tutt’altro che superflua, date le circostanze e la frequenza con cui incidenti di questo tipo si sono verificati durante la nostra permanenza nel paese. Inoltre, era un sollievo avere un posto, anche piccolo, dove poter stare da soli. Ogni camera aveva una seconda porta a vetri che si apriva su di una stretta veranda posta sul fianco del battello, dove non c’era quasi nessuno, e dove si poteva stare tranquillamente seduti a guardare il paesaggio mutevole. Perciò abbiamo preso possesso con piacere dei nuovi appartamenti.
 Le navi americane da me descritte finora avevano un aspetto diverso da ciò che noi inglesi siamo abituati a veder galleggiare sull’acqua, ma i battelli che si vedono nell’Ovest del paese sono ancora più lontani da ogni nostra idea in proposito.
Le navi americane da me descritte finora avevano un aspetto diverso da ciò che noi inglesi siamo abituati a veder galleggiare sull’acqua, ma i battelli che si vedono nell’Ovest del paese sono ancora più lontani da ogni nostra idea in proposito. Innanzitutto, non hanno l’alberatura, i cordami, i paranchi, le manovre e altre attrezzature del genere e nella loro forma non c’è nulla che ricordi la prua, la poppa, le fiancate o la chiglia di un’imbarcazione. Se non fosse che stanno nell’acqua e mostrano i due tamburi delle ruote a pale si potrebbe supporre, per quel che si vede, che siano degli arnesi destinati a compiere qualche servizio ignoto, all’asciutto in cima a una montagna.
Non c’è un ponte visibile, niente all’infuori di una lunga tettoia nera coperta di frammenti bruciati, sulla quale torreggiano due fumaioli, una rudimentale valvola di sicurezza e il gabbiotto di vetro del timoniere. Poco più in basso, lo sguardo incontra le finestre e le porte delle nostre camerette, che sembrano delle piccole case costruite sulla stessa strada con gusti diversi. L’insieme è sorretto da travi e da pali che poggiano su una chiatta sporca, alta pochi centimetri sulla superficie dell’acqua. Nello spazio fra le sovrastrutture e la chiatta ci sono le macchine e le caldaie, aperte alla pioggia ed ai venti. Se capita di incrociare di notte uno di questi battelli, si vede il fuoco delle caldaie e si sente il rumore che proviene da sotto il fragile castello di legno dipinto; le macchine non sorvegliate compiono il loro lavoro in mezzo alla folla degli oziosi, degli emigranti e dei loro bambini, che si pigiano sul ponte inferiore. Se si pensa che gli uomini che le maneggiano con noncuranza hanno un’esperienza di non più di sei mesi, ci si rende conto che la cosa strana non è il numero degli incidenti, ma l’arrivare a destinazione sani e salvi.
Al centro c’è una cabina stretta, della lunghezza del battello, su cui si aprono le due file di camerette. Una piccola parte della cabina, a poppa, è riservata alle donne, mentre a prua c’è il bar. Il centro è occupato da un lungo tavolo, alle due estremità ci sono le stufe. Sul ponte c’è il necessario per lavarsi, che è appena un po’ meglio di quello che c’era sul battello del canale.
Per quanto riguarda l’igiene personale e le abluzioni, le abitudini degli americani sono trascurate e ripugnanti e io sono portato a credere che questa sia la causa di molte delle loro malattie.
 Dovevamo passare tre giorni sul Messenger, per arrivare a Cincinnati il lunedì mattina, salvo incidenti. Ci venivano serviti tre pasti al giorno: la colazione alle sette, il pranzo a mezzogiorno e mezzo e la cena intorno alle sei. Ogni volta veniva messa sul tavolo, a disposizione di tutti, una quantità di piccoli piatti contenenti poche cose, di modo che, anche se l’insieme aveva l’aspetto di un festino, in realtà, salvo che per quelli che andavano matti per le barbabietole a fette, le lamelle di bue affumicato, i complicati miscugli di sottaceti gialli in una salsa a base di mais e di composta di mele o per le zucche, era solo un pasto leggero pronto a tutte le ore.
Dovevamo passare tre giorni sul Messenger, per arrivare a Cincinnati il lunedì mattina, salvo incidenti. Ci venivano serviti tre pasti al giorno: la colazione alle sette, il pranzo a mezzogiorno e mezzo e la cena intorno alle sei. Ogni volta veniva messa sul tavolo, a disposizione di tutti, una quantità di piccoli piatti contenenti poche cose, di modo che, anche se l’insieme aveva l’aspetto di un festino, in realtà, salvo che per quelli che andavano matti per le barbabietole a fette, le lamelle di bue affumicato, i complicati miscugli di sottaceti gialli in una salsa a base di mais e di composta di mele o per le zucche, era solo un pasto leggero pronto a tutte le ore. Alcuni passeggeri amavano mettere insieme quelle delizie (oltre alle marmellate dolci) per accompagnare e insaporire il maiale arrosto. Di solito quegli uomini e quelle donne, dispeptici, a pranzo e a cena mangiavano delle quantità inaudite di un pane di granturco caldo, favorevole alla digestione quanto un puntaspilli impastato. Chi non seguiva questa abitudine, preferendo servirsi più volte delle pietanze, generalmente leccava il proprio coltello e la propria forchetta, meditabondo, in attesa di decidere che cosa volesse prendere dopo. Poi li tirava fuori dalla bocca per immergerli nel piatto di portata, servirsi e rimettersi all’opera. A cena, da bere c’era soltanto acqua fresca dentro a grandi caraffe. Durante i pasti, nessuno rivolgeva la parola agli altri. Tutti i passeggeri erano molto cupi e sembravano avere dei terribili segreti gravanti sul loro animo. Non c’era conversazione, non c’erano risa, allegria o attività sociale, all’infuori degli sputi, fatti in una complicità silenziosa, attorno alla stufa, quando il pasto era terminato. Gli uomini sedevano a tavola muti e annoiati, come se la colazione, il pranzo e la cena fossero delle necessità naturali, non accompagnate da distensione o distrazione. Dopo aver mandato giù il pasto mandavano giù anche se stessi, in un lugubre silenzio. Se non li si fosse visti ancora legati a questi comportamenti animali si sarebbe stati tentati di concludere che l’elemento maschile della compagnia consistesse in malinconici spettri di contabili che la morte aveva inchiodato alla scrivania, tanto sembravano faticosamente immersi nei loro affari e nei loro calcoli. In confronto a loro, gli impresari di pompe funebri sarebbero sembrati dei buontemponi e, a paragone di questi pasti, una colazione funebre avrebbe un’aria di festa sfrenata.
Inoltre, le persone erano tutte identiche, non c’era diversità di carattere. Viaggiavano con lo stesso scopo, dicevano le stesse cose esprimendole nello stesso modo e andavano dietro le une alle altre come delle pecore. Da un capo all’altro della lunga tavola, era difficile trovare un uomo che fosse diverso dal suo vicino.
 Il fiume, vasto e maestoso, in certi punti del suo corso si allarga e si divide in due bracci con un’isola verde e boscosa al centro. Di tanto in tanto ci fermavamo qualche minuto per prendere legna per la caldaia o per far sbarcare dei passeggeri in qualche piccola città o villaggio (uso la parola città perché questo è il nome che si dà qui a qualunque centro abitato); ma le rive erano per lo più inabitate, selvagge, coperte di alberi le cui prime foglie avevano un verde vivo.
Il fiume, vasto e maestoso, in certi punti del suo corso si allarga e si divide in due bracci con un’isola verde e boscosa al centro. Di tanto in tanto ci fermavamo qualche minuto per prendere legna per la caldaia o per far sbarcare dei passeggeri in qualche piccola città o villaggio (uso la parola città perché questo è il nome che si dà qui a qualunque centro abitato); ma le rive erano per lo più inabitate, selvagge, coperte di alberi le cui prime foglie avevano un verde vivo. Per miglia e miglia, quelle solitudini erano prive di ogni traccia di vita umana o di impronte di passi; non si vedeva nulla che si muovesse, tranne la ghiandaia, il cui colore così vivo, eppure così delicato, faceva pensare a un fiore in volo.
Di quando in quando si vedeva una capanna di tronchi d’abete, annidata ai piedi di un’altura e circondata da un piccolo terreno disboscato, dalla quale si vedevano levarsi verso il cielo delle volute di fumo azzurro. Era stata costruita all’estremità di un povero campo di grano, disseminato di ceppi simili a quelli dei macellai. Talvolta si era appena finito di dissodare, gli alberi abbattuti giacevano ancora al suolo e si era cominciato a erigere la casupola di tronchi la mattina stessa. Mentre passavamo davanti a questi piccoli pezzi di terra, vedevamo il colono che si appoggiava alla scure o alla mazza e osservava con sguardo malinconico le persone venute dal mondo abitato. I suoi figli scivolavano fuori della capanna provvisoria, simile a una tenda da nomadi posata sul terreno, per battere le mani ed emettere delle grida. Solo il cane ci sbirciava con sospetto prima di levare la testa in direzione del viso del padrone, come se fosse irritato per l’improvvisa interruzione del lavoro ordinario e si disinteressasse alle persone che viaggiavano per loro piacere.
L’acqua del fiume ne aveva eroso le rive in alcuni punti, facendo cadere degli alberi imponenti che si erano abbattuti nella corrente. Alcuni erano là da così tanto tempo che erano ridotti a scheletri imbiancati, simili a quello dell’orso grigio, altri erano appena caduti e avevano ancora della terra nelle radici, mentre le loro punte verdi, immerse nell’acqua, continuavano a mettere nuovi germogli e nuovi rami. Alcuni scivolavano quasi via mentre li si stava guardando, altri erano immersi da così tanto tempo nell’acqua che le loro braccia spoglie e imbiancate spuntavano al centro della corrente e sembravano voler afferrare il battello per tirarlo giù in profondità.
In mezzo a uno scenario simile il nostro lento e ingombrante vascello si apriva la strada, rauco e arcigno, sbuffando a ogni colpo di pala. Il rumore era tale da svegliare, si sarebbe indotti a pensare, la schiera di indiani che dormono il loro sonno eterno sepolti in quell’altissimo tumulo, così antico che le radici delle querce imponenti e degli alberi della foresta circostante lo hanno raggiunto e così alto da confondersi con le alture naturali. Il fiume stesso, quasi a condividere i sentimenti di pietà per le tribù che, secoli fa, vivevano tranquille ignorando persino l’esistenza della razza bianca, dirotta il suo corso per gorgogliare vicino a quel tumulo e non c’è altro luogo dove l’Ohio scintilli di più che nell’Insenatura della Grande Tomba.
Questo è quel che vedevo mentre stavo seduto nella mia piccola veranda e scendeva lentamente la sera a trasformare il paesaggio. A un tratto, la nave si è fermata per far scendere alcuni emigranti.
La riva boscosa lungo cui avanzavamo rendeva la notte ancora più nera. Dopo aver costeggiato per un po’ un viluppo di cespugli, siamo sbucati in uno spazio aperto dove bruciavano degli alberi. Le forme dei rami e dei ramoscelli si stagliavano contro un vivo riflesso rossastro e sembravano crescere in un braciere, ravvivato dalla brezza della sera. Lo spettacolo era di quelli descritti nelle leggende delle foreste incantate, ma era triste vedere queste nobili opere della natura consumarsi così, spaventosamente sole! Quanti anni passeranno prima che la magia che li ha creati faccia ricrescere i loro simili su questo suolo? Ma il tempo verrà e quando il susseguirsi dei secoli futuri, resuscitando questi alberi dalle loro ceneri, avrà rigenerato le loro radici, uomini irrequieti ritorneranno a queste solitudini e altri loro compagni, in città lontane che ora giacciono in fondo al mare immerse nel sonno, leggeranno, in un linguaggio oggi sconosciuto alle nostre orecchie, ma molto antico per loro, di foreste primitive dove non era mai echeggiata la scure e il cui suolo non era mai stato calpestato dall’uomo.
Mezzanotte. Il sonno è venuto a cancellare questi paesaggi e questi pensieri. E il nuovo giorno illuminava di una luce dorata i tetti di una città animata, davanti al cui ampio molo lastricato abbiamo ormeggiato il nostro battello in mezzo ad altri, alle bandiere che sventolavano, alle ruote in movimento, come se nel raggio di mille miglia non ci fosse una strada o un pezzo di terra silenziosi e solitari.
 Cincinnati è una bella città accogliente, prospera e animata. Non ho visto spesso dei luoghi che a prima vista si presentino allo straniero sotto a un aspetto così felice e piacevole, con le sue casette linde, dipinte di rosso e di bianco, le strade ben lastricate, i marciapiedi ricoperti di lucenti piastrelle. E questa prima impressione non si dissipa per nulla quando la si guarda più da vicino. Le strade sono larghe e aerate, le botteghe sono eccellenti, le case sono particolarmente notevoli per l’eleganza e per la pulizia. Negli stili degli edifici moderni c’è un’atmosfera di creatività e di fantasia, che dopo la monotona piattezza del battello è eminentemente gradevole, anche perché ricorda che simili qualità esistono ancora. L’inclinazione a decorare queste case graziose e a renderle attraenti porta gli abitanti a piantare dei fiori e degli alberi e ad aver cura dei loro giardini, la cui vista, per chi cammina nella strada, è riposante e gradevole. L’aspetto della città, situata in un anfiteatro circondato da colline, in un quadro di grande bellezza, e dell’attiguo sobborgo vicino al monte Auburn, mi ha totalmente conquistato.
Cincinnati è una bella città accogliente, prospera e animata. Non ho visto spesso dei luoghi che a prima vista si presentino allo straniero sotto a un aspetto così felice e piacevole, con le sue casette linde, dipinte di rosso e di bianco, le strade ben lastricate, i marciapiedi ricoperti di lucenti piastrelle. E questa prima impressione non si dissipa per nulla quando la si guarda più da vicino. Le strade sono larghe e aerate, le botteghe sono eccellenti, le case sono particolarmente notevoli per l’eleganza e per la pulizia. Negli stili degli edifici moderni c’è un’atmosfera di creatività e di fantasia, che dopo la monotona piattezza del battello è eminentemente gradevole, anche perché ricorda che simili qualità esistono ancora. L’inclinazione a decorare queste case graziose e a renderle attraenti porta gli abitanti a piantare dei fiori e degli alberi e ad aver cura dei loro giardini, la cui vista, per chi cammina nella strada, è riposante e gradevole. L’aspetto della città, situata in un anfiteatro circondato da colline, in un quadro di grande bellezza, e dell’attiguo sobborgo vicino al monte Auburn, mi ha totalmente conquistato.