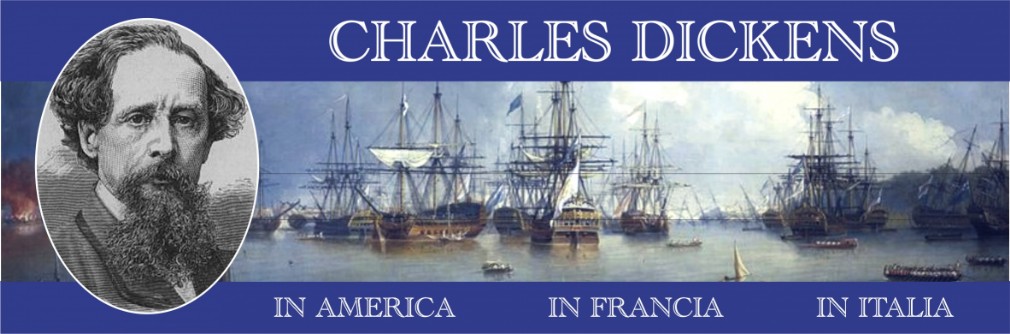INTRODUZIONE
Il naufragio della Golden Mary è una delle storie di Natale di Dickens. Contiene alcuni dei temi natalizi caratteristici dello scrittore - l’attrattiva rappresentata dalla conquista del benessere materiale, il potere che ha il passato di influenzare e di dare forma al presente, l’innocenza salvifica dell’infanzia, il destino a cui non ci si può sottrarre - ma, a differenza delle altre storie, questa ha un tono malinconico ed è pervasa da un’atmosfera cupa e inquietante. Anche fra i passeggeri ci sono alcuni personaggi tipicamente dickensiani: la giovane madre e la figlia dalla bellezza angelica, che muore drammaticamente durante il naufragio; la ragazza che va a raggiungere il fidanzato andato in rovina durante la corsa all’oro; l’anziano avaro ed egoista, anche lui ansioso di raggiungere il paese il cui suolo trabocca del metallo prezioso…
 Dickens aveva cominciato a scrivere la storia nel settembre del 1856 e l’ha pubblicata il 6 dicembre successivo sulla rivista settimanale Household Words, da lui curata. Nelle edizioni successive, del drammatico naufragio nelle gelide acque dell’Oceano sono state pubblicate solo le parti scritte da Dickens, mentre è stata soppressa la descrizione del salvataggio finale, opera dal suo amico e collaboratore Wilkie Collins. Così per decenni, nella storia incompleta, i passeggeri rimanevano abbandonati alla deriva nei loro battelli scoperti, senza alcuna nave in vista…
Dickens aveva cominciato a scrivere la storia nel settembre del 1856 e l’ha pubblicata il 6 dicembre successivo sulla rivista settimanale Household Words, da lui curata. Nelle edizioni successive, del drammatico naufragio nelle gelide acque dell’Oceano sono state pubblicate solo le parti scritte da Dickens, mentre è stata soppressa la descrizione del salvataggio finale, opera dal suo amico e collaboratore Wilkie Collins. Così per decenni, nella storia incompleta, i passeggeri rimanevano abbandonati alla deriva nei loro battelli scoperti, senza alcuna nave in vista… In quel periodo Dickens stava attraversando una crisi familiare. Dopo aver represso per anni la tensione causatagli dal matrimonio, questa era infine esplosa, provocandogli una grande instabilità emotiva. Per anni si era sentito oppresso e aveva deciso alla fine di sottrarsi alla prigione in cui gli sembrava di vivere. E, proprio come i naufraghi della Golden Mary, che hanno dovuto abbandonare la nave fino a quel momento sicura, per trasferirsi nelle fragili scialuppe, lui ha abbandonato il proprio focolare per avventurarsi nelle acque tempestose della relazione con la giovane attrice Ellen Terry. Le due voci narranti del racconto sono quelle del comandante della nave, in cui si identifica Dickens e quella del comandante in seconda, in cui si identifica Collins. Essi usano delle espressioni marinaresche tipiche anche per riferirsi a situazioni di vita quotidiana.
 Il viaggio della Golden Mary e della seconda imbarcazione inizia in modo favorevole. Le due navi si dirigono verso la California, dove è in pieno svolgimento la corsa all’oro. Purtroppo, dopo sessantasei giorni di navigazione, la Golden Mary urta un iceberg galleggiante, vi si schianta e si capovolge. “L’oscurità del cielo era tale – scrive Dickens - da dare l’impressione di guardare attraverso una benda nera posta davanti agli occhi”.
Il viaggio della Golden Mary e della seconda imbarcazione inizia in modo favorevole. Le due navi si dirigono verso la California, dove è in pieno svolgimento la corsa all’oro. Purtroppo, dopo sessantasei giorni di navigazione, la Golden Mary urta un iceberg galleggiante, vi si schianta e si capovolge. “L’oscurità del cielo era tale – scrive Dickens - da dare l’impressione di guardare attraverso una benda nera posta davanti agli occhi”. In quelle condizioni difficili, i passeggeri vengono aiutati a trasferirsi sulle due scialuppe, dove passeranno molte settimane a cercare di sopravvivere con il poco cibo a disposizione, trascinati dalle correnti e dai venti.  Il capitano è una figura toccante per il suo eroismo, per il modo in cui infonde coraggio a tutti, per come invita gli sventurati a raccontare delle storie e a cantare, dato che la musica e la narrazione hanno un potere corroborante sul morale dei viaggiatori. Il raccontare l’un l’altro delle storie, infatti, aiuta a limitare il senso di perdita e di isolamento, a difendersi dalla paura e dal senso di sfiducia e depressione. Tutti si sentono più forti nell’affrontare la fame, il freddo, la pioggia e il vento forte. Nei giorni in cui la situazione è più critica, poi, il comandante fa passare, attraverso le storie, il messaggio che il cannibalismo è inammissibile. Poi, finalmente, quando nella loro grande debolezza essi hanno ormai l’impressione che nell’ambiente circostante si muovano dei fantasmi che li attirano verso la morte, delle apparizioni che indeboliscono le loro ultime fragili certezze e gli rivelano quanto sia facile e attraente scivolare nel mondo dell’aldilà, le loro scialuppe vengono avvistate da una nave di passaggio.
Il capitano è una figura toccante per il suo eroismo, per il modo in cui infonde coraggio a tutti, per come invita gli sventurati a raccontare delle storie e a cantare, dato che la musica e la narrazione hanno un potere corroborante sul morale dei viaggiatori. Il raccontare l’un l’altro delle storie, infatti, aiuta a limitare il senso di perdita e di isolamento, a difendersi dalla paura e dal senso di sfiducia e depressione. Tutti si sentono più forti nell’affrontare la fame, il freddo, la pioggia e il vento forte. Nei giorni in cui la situazione è più critica, poi, il comandante fa passare, attraverso le storie, il messaggio che il cannibalismo è inammissibile. Poi, finalmente, quando nella loro grande debolezza essi hanno ormai l’impressione che nell’ambiente circostante si muovano dei fantasmi che li attirano verso la morte, delle apparizioni che indeboliscono le loro ultime fragili certezze e gli rivelano quanto sia facile e attraente scivolare nel mondo dell’aldilà, le loro scialuppe vengono avvistate da una nave di passaggio.  È un brigantino inglese che, quando i marinai non ce la fanno più a emettere le grida coordinate al sollevarsi delle onde, con la speranza di essere ascoltati, li prende a bordo e li salva.
È un brigantino inglese che, quando i marinai non ce la fanno più a emettere le grida coordinate al sollevarsi delle onde, con la speranza di essere ascoltati, li prende a bordo e li salva.
 Il capitano è una figura toccante per il suo eroismo, per il modo in cui infonde coraggio a tutti, per come invita gli sventurati a raccontare delle storie e a cantare, dato che la musica e la narrazione hanno un potere corroborante sul morale dei viaggiatori. Il raccontare l’un l’altro delle storie, infatti, aiuta a limitare il senso di perdita e di isolamento, a difendersi dalla paura e dal senso di sfiducia e depressione. Tutti si sentono più forti nell’affrontare la fame, il freddo, la pioggia e il vento forte. Nei giorni in cui la situazione è più critica, poi, il comandante fa passare, attraverso le storie, il messaggio che il cannibalismo è inammissibile. Poi, finalmente, quando nella loro grande debolezza essi hanno ormai l’impressione che nell’ambiente circostante si muovano dei fantasmi che li attirano verso la morte, delle apparizioni che indeboliscono le loro ultime fragili certezze e gli rivelano quanto sia facile e attraente scivolare nel mondo dell’aldilà, le loro scialuppe vengono avvistate da una nave di passaggio.
Il capitano è una figura toccante per il suo eroismo, per il modo in cui infonde coraggio a tutti, per come invita gli sventurati a raccontare delle storie e a cantare, dato che la musica e la narrazione hanno un potere corroborante sul morale dei viaggiatori. Il raccontare l’un l’altro delle storie, infatti, aiuta a limitare il senso di perdita e di isolamento, a difendersi dalla paura e dal senso di sfiducia e depressione. Tutti si sentono più forti nell’affrontare la fame, il freddo, la pioggia e il vento forte. Nei giorni in cui la situazione è più critica, poi, il comandante fa passare, attraverso le storie, il messaggio che il cannibalismo è inammissibile. Poi, finalmente, quando nella loro grande debolezza essi hanno ormai l’impressione che nell’ambiente circostante si muovano dei fantasmi che li attirano verso la morte, delle apparizioni che indeboliscono le loro ultime fragili certezze e gli rivelano quanto sia facile e attraente scivolare nel mondo dell’aldilà, le loro scialuppe vengono avvistate da una nave di passaggio.  È un brigantino inglese che, quando i marinai non ce la fanno più a emettere le grida coordinate al sollevarsi delle onde, con la speranza di essere ascoltati, li prende a bordo e li salva.
È un brigantino inglese che, quando i marinai non ce la fanno più a emettere le grida coordinate al sollevarsi delle onde, con la speranza di essere ascoltati, li prende a bordo e li salva.Gli inglesi dicono che Dickens, nato a Portsmouth, avesse acqua salata nelle vene, volendo significare la sua grande capacità di descrivere con verosimiglianza e abbondanza di particolari precisi i viaggi per mare, con i pericoli rappresentati dai cambiamenti di umore dello stesso, ma anche quelli rappresentati dalle navi pirata, che spesso approfittavano delle tempeste per depredare i piccoli battelli. Perciò l’apparizione di un’altra imbarcazione poteva anche significare qualcosa di molto diverso da un salvataggio, ma, per fortuna, nel caso della Golden Mary tutto si è risolto positivamente.
IL NAUFRAGIO
Sono andato a far pratica di mare all’età di dodici anni e da allora ho incontrato molte volte il brutto tempo, tanto in senso reale quanto in senso metaforico. Sono sempre stato dell’opinione - sin da quando ricordo di averne avuta una - che l’uomo che conosce un solo argomento è quasi altrettanto noioso di quello che non ne conosce alcuno. Perciò, nel corso della mia vita, ho cercato di apprendere più cose possibili, e, anche se non sono un uomo istruito, sono in grado, grazie al cielo, di occuparmi di molte cose in modo intelligente.
Qualcuno, leggendo queste parole, potrebbe supporre che io abbia l’abitudine di dire degli sproloqui su me stesso. Ma non è così. Allo stesso modo in cui, quando entro in una stanza piena di sconosciuti devo essere presentato o presentarmi io stesso, mi sono preso la libertà di buttar giù queste poche note per dire chi io sono e che cosa ho fatto. Aggiungo solo che il mio nome è William George Ravender, che sono nato a Penrith sei mesi dopo l’annegamento di mio padre in mare, e che oggi, secondo giorno di questa settimana di Natale del 1856, compio cinquantasei anni.
 Quando ha cominciato a diffondersi la voce che in California c’era l’oro – che, come molti ricorderanno, è stato prima che lo si scoprisse anche nella colonia britannica dell’Australia – io ero nelle Indie occidentali, a praticare il commercio fra le isole. Essendo comandante e comproprietario di un piccolo schooner svolgevo un lavoro fatto su misura per me e mi occupavo di quello. Di conseguenza, l’oro della California non era affar mio.
Quando ha cominciato a diffondersi la voce che in California c’era l’oro – che, come molti ricorderanno, è stato prima che lo si scoprisse anche nella colonia britannica dell’Australia – io ero nelle Indie occidentali, a praticare il commercio fra le isole. Essendo comandante e comproprietario di un piccolo schooner svolgevo un lavoro fatto su misura per me e mi occupavo di quello. Di conseguenza, l’oro della California non era affar mio.Ma, dopo il mio ritorno in Inghilterra, la cosa era chiara come una mano tenuta davanti al viso nell’ora di mezzogiorno. C’era oro della California nei musei, nei negozi degli orafi, e la prima volta che sono andato alla Borsa ho incontrato un amico, marinaio come me, con una pepita californiana appesa alla catena dell’orologio. L’ho soppesata. Somigliava a una noce dalla superficie irregolare che fosse stata riprodotta mediante galvanotipia, come non ne avevo mai viste prima.
Sono celibe (lei era troppo buona per questo mondo ed è morta sei settimane prima del giorno del matrimonio) e così, quando sono a terra, vivo nella mia casa di Poplar, di cui si prende cura, come se fosse una nave, una vecchia signora che lavorava già come cameriera per mia madre prima della mia nascita. È gentile e onesta come nessun’altra donna al mondo. Mi vuole bene come se avesse un solo figlio e quel figlio fossi io. So bene che, ovunque io stia navigando, lei non si addormenta mai prima di aver detto: “Dio misericordioso! Benedici e custodisci William George Ravender e fallo tornare a casa sano e salvo, con l’intercessione di Cristo nostro Salvatore!”. Il mio pensiero è tornato spesso a lei nei momenti di pericolo e sono sicuro che questo non mi abbia fatto male.
Dopo un lungo periodo passato in mare in mezzo alle isole, avevo contratto una brutta febbre, una cosa per me insolita e per questo vivevo tranquillo nella mia casa di Poplar, con questa vecchia signora. Finalmente, dopo aver letto tutti i libri su cui ero riuscito a mettere le mani e sentendomi di nuovo forte e sano, ero andato a passeggio in Leadenhall Street, nella City. Stavo pensando di tornare indietro quando mi sono imbattuto nell’uomo che io chiamo Smithick e Watersby di Liverpool. Casualmente, avevo alzato gli occhi da un cronometro nautico che stavo guardando in una vetrina e l’avevo visto sporgersi in avanti e farmi un cenno.
 Dicendo Smithick e Watersby, non mi riferisco a due persone con cui io sia entrato in contatto e non credo neppure che in quella ditta di Liverpool ci sia mai stato qualcuno che si chiamasse così. Mi riferisco invece al nome della ditta stessa, dove non ha mai messo piede un mercante più saggio e un gentiluomo più sincero.
Dicendo Smithick e Watersby, non mi riferisco a due persone con cui io sia entrato in contatto e non credo neppure che in quella ditta di Liverpool ci sia mai stato qualcuno che si chiamasse così. Mi riferisco invece al nome della ditta stessa, dove non ha mai messo piede un mercante più saggio e un gentiluomo più sincero. “Mio caro capitano Ravender – mi ha detto – voi siete l’uomo che più di tutti desideravo incontrare. Stavo venendo a cercarvi.”
“Bene – ho risposto – allora sembra proprio che fosse destino incontrarmi, no?” L’ho quindi preso sottobraccio e ci siamo diretti verso il Royal Exchange. Una volta raggiunta la parte posteriore, abbiamo camminato per quasi un’ora avanti indietro sotto alla torre dell’orologio, perché aveva molte cose da dirmi. Voleva noleggiare una nave per portare in California le merci necessarie ai cercatori d’oro e agli emigranti e portare indietro l’oro acquistato. Non sto a descrivere i particolari di quel progetto, non ne ho il diritto, dico solo che era indubbiamente molto originale, valido, sicuro e redditizio.
Me lo ha comunicato con grande franchezza, come se ne facessi già parte. Poi mi ha fatto l’offerta più bella che abbia mai ricevuto o che sia mai stata fatta a un capitano della Marina e ha terminato con la frase:
“Ravender, voi sapete bene che su quella costa c’è l’anarchia caratteristica del tipo di sviluppo che ha avuto. Equipaggi di navi in partenza disertano appena hanno toccato terra, equipaggi di navi dirette in patria con alti stipendi uccidono il comandante e si impadroniscono dell’oro; non ci si può fidare di alcuno e il diavolo sembra farla da padrone. Ora – ha aggiunto – voi conoscete la mia opinione su di voi, sapete che vi ritengo l’unico uomo la cui integrità, discrezione ed energia ecc…”. Non voglio ripetere quello che ha detto, anche se l’ho apprezzato molto.
Tuttavia, anche se il mio stato d’animo era favorevole al viaggio, avevo dei dubbi circa la sua realizzazione. Sapevo che le difficoltà e i pericoli che esso conteneva erano maggiori di quelli di un viaggio normale. Non si può dire che non fossi pronto ad affrontarli, ma a mio parere un uomo deve prima prendere in considerazione ciò che essi costituiscono e dire a se stesso:  “Nessun rischio mi prenderà di sorpresa, so qual è la cosa migliore da fare in ogni situazione difficile, tutto il resto è nelle mani di Colui a cui affido me stesso.” Avevo quindi esaminato tutte le minacce a cui ero riuscito a pensare, dalla tempesta al naufragio, all’incendio a bordo e penso che sarei stato preparato a fare il necessario per salvare le vite di cui ero responsabile.
“Nessun rischio mi prenderà di sorpresa, so qual è la cosa migliore da fare in ogni situazione difficile, tutto il resto è nelle mani di Colui a cui affido me stesso.” Avevo quindi esaminato tutte le minacce a cui ero riuscito a pensare, dalla tempesta al naufragio, all’incendio a bordo e penso che sarei stato preparato a fare il necessario per salvare le vite di cui ero responsabile.
 “Nessun rischio mi prenderà di sorpresa, so qual è la cosa migliore da fare in ogni situazione difficile, tutto il resto è nelle mani di Colui a cui affido me stesso.” Avevo quindi esaminato tutte le minacce a cui ero riuscito a pensare, dalla tempesta al naufragio, all’incendio a bordo e penso che sarei stato preparato a fare il necessario per salvare le vite di cui ero responsabile.
“Nessun rischio mi prenderà di sorpresa, so qual è la cosa migliore da fare in ogni situazione difficile, tutto il resto è nelle mani di Colui a cui affido me stesso.” Avevo quindi esaminato tutte le minacce a cui ero riuscito a pensare, dalla tempesta al naufragio, all’incendio a bordo e penso che sarei stato preparato a fare il necessario per salvare le vite di cui ero responsabile.Vedendomi pensieroso, il mio amico mi ha proposto di lasciarmi solo a passeggiare e di incontrarmi più tardi al suo club in Pall Mall per pranzare. Ho accettato l’invito e ho continuato a camminare per un paio d’ore, come se fossi stato sulla tolda di una nave, alzando ogni tanto gli occhi sulla banderuola come se fosse stato il sartiame e gettando ogni tanto occhiate verso Cornhill come avrei fatto con la murata.
Abbiamo continuato a parlare del piano a pranzo e anche dopo. Gli ho detto che cosa pensavo del progetto e lui ha approvato la mia idea. Poi ho aggiunto che avevo quasi deciso, anche se non del tutto.
“Bene! – mi ha risposto – venite domani con me a Liverpool a vedere la Golden Mary.” Il nome mi piaceva – si chiamava Mary e Golden poteva indicare il suo valore - così, quando ho detto che sarei andato a Liverpool, mi sembrava che la decisione di imbarcarmi fosse presa. Due mattine dopo eravamo a bordo della Golden Mary. Dal fatto che il mio amico mi aveva chiesto di andare a vederla avrei dovuto capire che aspetto avesse. E, a mio parere, essa aveva la bellezza più perfetta e delicata che mi fosse mai capitato di vedere.
 Abbiamo ispezionato tutte le ordinate, poi siamo tornati indietro alla passerella da sbarco per scendere a terra e qui ho porto la mano al mio amico.
Abbiamo ispezionato tutte le ordinate, poi siamo tornati indietro alla passerella da sbarco per scendere a terra e qui ho porto la mano al mio amico.“Stringetela – gli ho detto – e stringetela forte. Assumerò il comando di questa nave e apparterrò a lei, oltre che a voi, se potrò avere John Steadiman come comandante in seconda.”
John Steadiman aveva fatto quattro viaggi con me. Alla partenza del primo viaggio, verso la Cina, egli era terzo ufficiale. Quando è tornato era secondo ufficiale. Negli altri tre viaggi, egli era il mio primo ufficiale. Adesso, al momento di noleggiare la Golden Mary, aveva trentadue anni. Era un tipo energico, sveglio, con gli occhi azzurri, la figura ben proporzionata anche se al di sotto della media, era sempre disponibile e mai fra i piedi. La sua faccia piaceva a tutti, in particolare ai bambini e aveva l’abitudine di cantare allegramente come un merlo o come un perfetto marinaio.
In meno di un minuto siamo saliti su una di quelle vetture a nolo di Liverpool e abbiamo girato senza interruzione per circa tre ore, alla ricerca di John. Era tornato un mese prima dalla Tasmania e avevo sentito dire che si stava concedendo un periodo di riposo a Liverpool. Abbiamo chiesto di lui in diversi posti e anche in due pensioni di cui era stato cliente.  Abbiamo saputo che aveva passato una settimana in entrambe, ma che era partito per salire in testa d’albero della montagna più alta del Galles (così aveva detto alle persone della locanda) e nessuno sapeva dove fosse né se sarebbe tornato. Era sorprendente, tuttavia, vedere come ogni viso si illuminasse appena si pronunciava il suo nome.
Abbiamo saputo che aveva passato una settimana in entrambe, ma che era partito per salire in testa d’albero della montagna più alta del Galles (così aveva detto alle persone della locanda) e nessuno sapeva dove fosse né se sarebbe tornato. Era sorprendente, tuttavia, vedere come ogni viso si illuminasse appena si pronunciava il suo nome.
 Abbiamo saputo che aveva passato una settimana in entrambe, ma che era partito per salire in testa d’albero della montagna più alta del Galles (così aveva detto alle persone della locanda) e nessuno sapeva dove fosse né se sarebbe tornato. Era sorprendente, tuttavia, vedere come ogni viso si illuminasse appena si pronunciava il suo nome.
Abbiamo saputo che aveva passato una settimana in entrambe, ma che era partito per salire in testa d’albero della montagna più alta del Galles (così aveva detto alle persone della locanda) e nessuno sapeva dove fosse né se sarebbe tornato. Era sorprendente, tuttavia, vedere come ogni viso si illuminasse appena si pronunciava il suo nome. Eravamo stupiti di aver avuto così poca fortuna e avevamo cambiato rotta, dirigendo la prua della nave verso altri miei amici quando, mentre camminavamo lentamente per strada, ho scorto John che usciva da un negozio di giocattoli. Aveva in braccio un bambino e accompagnava alla carrozza due donne molto graziose che, come mi avrebbe detto poi, non aveva mai visto né conosciuto prima. Le aveva però viste comprare al bambino una sgangherata arca di Noè, con la prua fatta male ed era stato colpito. Per questo aveva chiesto il permesso alle signore di poter offrire al bambino un cutter, più decente, che era in vetrina, per impedire che quel bambino così bello crescesse con un’idea sbagliata dell’architettura navale.
Siamo rimasti alla larga fino a quando il cocchiere delle due signore non si è allontanato, poi abbiamo chiamato John. Quando è salito a bordo, gli ho detto, con tono molto serio, ciò che avevo detto al mio amico. La cosa, come ha poi detto lui stesso, lo ha molto colpito e si vedeva che era scosso.
“Capitano Ravender – sono state le parole di John Steadiman – il vostro apprezzamento è un grande onore per me e io navigherò con voi intorno al mondo per i prossimi vent’anni, a un vostro cenno e sarò sempre al vostro fianco!”. A questo punto ho sentito che la cosa era fatta e che la Golden Mary era pronta a prendere il largo.
 Sotto i piedi di Smithick e Watersby non è cresciuta l’erba. Nel giro di quindici giorni le vele erano attrezzate e avevamo cominciato a stivare le merci. John era sempre a bordo, a controllare con lo sguardo l’immagazzinamento e in qualunque momento salissi a bordo lo vedevo nella stiva, al boccaporto, sul ponte o a riordinare la cabina, appendendovi dei quadri di rose d’Inghilterra, di campanule di Scozia, di quadrifogli d’Irlanda. Di certo lo sentivo cantare come un merlo.
Sotto i piedi di Smithick e Watersby non è cresciuta l’erba. Nel giro di quindici giorni le vele erano attrezzate e avevamo cominciato a stivare le merci. John era sempre a bordo, a controllare con lo sguardo l’immagazzinamento e in qualunque momento salissi a bordo lo vedevo nella stiva, al boccaporto, sul ponte o a riordinare la cabina, appendendovi dei quadri di rose d’Inghilterra, di campanule di Scozia, di quadrifogli d’Irlanda. Di certo lo sentivo cantare come un merlo.Portavamo venti passeggeri, anche se, appena era stato messo fuori il cartello, avevamo avuto delle richieste per un numero di venti volte superiore. Per l’equipaggio, io e John avevamo ingaggiato le persone più fidate disponibili al porto. Così, alle quattro e un quarto del pomeriggio del 7 marzo 1851, siamo partiti con la nostra nave robusta, riparata e ben equipaggiata sotto ogni aspetto, dirigendoci al largo con un vento favorevole.
Fino a quel momento non avevo avuto occasione di approfondire la conoscenza dei passeggeri. La maggior parte di loro stava distesa nelle cuccette in preda al mal di mare e, per familiarizzare, mi sono recato a trovarli, dicendogli quello che era meglio fare e persuadendoli a lasciare le brandine e a salire in coperta a respirare la brezza marina, distraendoli con una battuta o con una parola di conforto, in un modo più amichevole di quanto non sarebbe stato possibile se avessi solo conversato con loro a tavola.
 Fra i passeggeri c’erano una sposa giovane e florida dagli occhi splendenti, che andava a raggiungere il marito in California insieme alla figlia, una bambina di tre anni che il padre non aveva mai conosciuto; una donna taciturna in gramaglie sulla trentina, che andava a raggiungere un fratello; un anziano gentiluomo, che sarebbe stato simile a un falco, se avesse avuto degli occhi migliori e non così arrossati, che non faceva che parlare della scoperta dell’oro mattina, mezzogiorno e sera. Ma non era dato sapere se pensasse di scavare la terra con le sue vecchie braccia, oppure speculare comprando pepite, o truffare barattandole o portandole via ad altri con l’inganno. Era un segreto che non ha mai svelato.
Fra i passeggeri c’erano una sposa giovane e florida dagli occhi splendenti, che andava a raggiungere il marito in California insieme alla figlia, una bambina di tre anni che il padre non aveva mai conosciuto; una donna taciturna in gramaglie sulla trentina, che andava a raggiungere un fratello; un anziano gentiluomo, che sarebbe stato simile a un falco, se avesse avuto degli occhi migliori e non così arrossati, che non faceva che parlare della scoperta dell’oro mattina, mezzogiorno e sera. Ma non era dato sapere se pensasse di scavare la terra con le sue vecchie braccia, oppure speculare comprando pepite, o truffare barattandole o portandole via ad altri con l’inganno. Era un segreto che non ha mai svelato. Queste tre persone e la bambina sono stati i primi a sentirsi un po’ meglio. La bambina era molto attraente e si era affezionata a me, anche se devo ammettere che il posto occupato da me e da Steadiman nel suo piccolo libro grazioso era l’inverso che nella realtà, dato che in esso lui era il comandante e io ero il primo ufficiale. Era bello osservarla insieme a John ed era altrettanto bello osservare John insieme a lei. Pochi, vedendolo giocare a nascondino attorno all’albero maestro, avrebbero creduto che era lo stesso uomo che, al largo di Saugar Point, aveva colpito a morte con una sbarra un malese e un maltese, che stavano sgusciando giù per la scaletta delle cabine del brigantino Old England con un coltello in mano, mentre il capitano era a letto ammalato. Eppure lo aveva fatto e ne avrebbe affrontati altri sei, anche con le spalle contro la murata. La giovane madre era la signora Atherfield, la giovane donna in nero era la signorina Coleshaw, il vecchio gentiluomo era il signor Rarx.
 La bambina, di nome Lucy, aveva una massa di capelli biondi e lucenti, che le ricadevano in riccioli attorno al volto, e per questo Steadiman aveva deciso di chiamarla Golden Lucy. Così, avevamo Golden Lucy e la Golden Mary. John aveva talmente trasformato la nave in un terreno di gioco che penso che la bambina la considerasse una cosa viva, una compagna di svaghi animata che andava nella sua stessa direzione. Le piaceva stare accanto al timone e, quando mi trovavo vicino al timoniere e c’era bel tempo, la ascoltavo mentre parlava alla nave, stando seduta ai miei piedi. Immagino che nessuna bambina abbia mai avuto un giocattolo simile prima di lei, che trattava la Golden Mary come una bambola, addobbandola con dei nastri e dei piccoli fronzoli attorno alle caviglie. Nessuno li toccava se non per impedire che il vento li portasse via.
La bambina, di nome Lucy, aveva una massa di capelli biondi e lucenti, che le ricadevano in riccioli attorno al volto, e per questo Steadiman aveva deciso di chiamarla Golden Lucy. Così, avevamo Golden Lucy e la Golden Mary. John aveva talmente trasformato la nave in un terreno di gioco che penso che la bambina la considerasse una cosa viva, una compagna di svaghi animata che andava nella sua stessa direzione. Le piaceva stare accanto al timone e, quando mi trovavo vicino al timoniere e c’era bel tempo, la ascoltavo mentre parlava alla nave, stando seduta ai miei piedi. Immagino che nessuna bambina abbia mai avuto un giocattolo simile prima di lei, che trattava la Golden Mary come una bambola, addobbandola con dei nastri e dei piccoli fronzoli attorno alle caviglie. Nessuno li toccava se non per impedire che il vento li portasse via.Naturalmente mi prendevo cura delle due donne, le chiamavo ‘mie care’ e loro non se ne avevano a male, perché il mio tono era paterno e protettivo. A tavola, avevo assegnato loro i due posti accanto a me, la signora Atherfield era alla mia destra e la signorina Coleshaw alla mia sinistra. A quest’ultima ho chiesto di servire la colazione, alla prima ho chiesto di servire il tè. Inoltre, in loro presenza, ho detto al mio domestico di colore: “Tom Snow, queste due signore sono in egual misura le padrone di casa e tu, in egual misura, dovrai obbedire ai loro ordini.” A questa affermazione, Tom si è messo a ridere, insieme a tutti gli altri.
 Il vecchio signor Rarx non era di aspetto gradevole e non era neanche una piacevole compagnia per fare conversazione. Era impossibile non accorgersi di quanto fosse meschino ed egoista e di quanto, negli anni, si fosse allontanato dalla rotta giusta, andando alla deriva. Con noi si comportava bene, come tutti, e non c’erano liti né a prua né a poppa, ma voglio dire che non era certo l’uomo che si sarebbe scelto come commensale. Se uno avesse potuto scegliere, si sarebbe spinto a dire: “No! Lui no!” C’era tuttavia una curiosa contraddizione nel signor Rarx. Mentre sembrava l’ultima persona sulla terra che potesse interessarsi a un bambino o a un qualsiasi essere umano, egli al contrario aveva sviluppato uno straordinario interesse per la piccola. Manifestava disagio se lei, sul ponte, stava a lungo fuori dalla sua vista. Temeva che potesse cadere in mare o che scivolasse giù dal boccaporto o dal bozzello, che qualche parte del sartiame potesse colpirla nel corso delle manovre o che si ferisse in qualche altro modo. La guardava e la toccava come una cosa preziosa, si preoccupava per la sua salute e supplicava costantemente la madre di fare attenzione. La cosa curiosa era che la bambina non lo amava affatto, rifuggiva da lui e non gli avrebbe nemmeno porto la mano se non fosse stata convinta da altri con paziente insistenza. Tutte le persone a bordo avevano notato questa situazione e non se la spiegavano, anche se era una cosa evidente. Una volta che il signor Rarx non era nei paraggi, John Steadiman aveva detto che se la Golden Mary provava una qualche tenerezza per il vecchio gentiluomo che trasportava, essa doveva essere molto gelosa di Golden Lucy.
Il vecchio signor Rarx non era di aspetto gradevole e non era neanche una piacevole compagnia per fare conversazione. Era impossibile non accorgersi di quanto fosse meschino ed egoista e di quanto, negli anni, si fosse allontanato dalla rotta giusta, andando alla deriva. Con noi si comportava bene, come tutti, e non c’erano liti né a prua né a poppa, ma voglio dire che non era certo l’uomo che si sarebbe scelto come commensale. Se uno avesse potuto scegliere, si sarebbe spinto a dire: “No! Lui no!” C’era tuttavia una curiosa contraddizione nel signor Rarx. Mentre sembrava l’ultima persona sulla terra che potesse interessarsi a un bambino o a un qualsiasi essere umano, egli al contrario aveva sviluppato uno straordinario interesse per la piccola. Manifestava disagio se lei, sul ponte, stava a lungo fuori dalla sua vista. Temeva che potesse cadere in mare o che scivolasse giù dal boccaporto o dal bozzello, che qualche parte del sartiame potesse colpirla nel corso delle manovre o che si ferisse in qualche altro modo. La guardava e la toccava come una cosa preziosa, si preoccupava per la sua salute e supplicava costantemente la madre di fare attenzione. La cosa curiosa era che la bambina non lo amava affatto, rifuggiva da lui e non gli avrebbe nemmeno porto la mano se non fosse stata convinta da altri con paziente insistenza. Tutte le persone a bordo avevano notato questa situazione e non se la spiegavano, anche se era una cosa evidente. Una volta che il signor Rarx non era nei paraggi, John Steadiman aveva detto che se la Golden Mary provava una qualche tenerezza per il vecchio gentiluomo che trasportava, essa doveva essere molto gelosa di Golden Lucy. Prima di andare avanti con il racconto, dirò che la nave era un brigantino a palo con una stazza di trecento tonnellate, un equipaggio di diciotto marinai, un secondo ufficiale accanto a John, un carpentiere, un fabbro armaiolo, e due mozzi, uno dei quali era un ragazzo scozzese, povero disgraziato.  A bordo avevamo una scialuppa capace di trasportare venticinque persone, un cutter, capace di trasportarne quindici, e un battellino, con dieci posti, adatto a passare attraverso i frangenti. Questa era la capacità di trasporto delle imbarcazioni.
A bordo avevamo una scialuppa capace di trasportare venticinque persone, un cutter, capace di trasportarne quindici, e un battellino, con dieci posti, adatto a passare attraverso i frangenti. Questa era la capacità di trasporto delle imbarcazioni.
 A bordo avevamo una scialuppa capace di trasportare venticinque persone, un cutter, capace di trasportarne quindici, e un battellino, con dieci posti, adatto a passare attraverso i frangenti. Questa era la capacità di trasporto delle imbarcazioni.
A bordo avevamo una scialuppa capace di trasportare venticinque persone, un cutter, capace di trasportarne quindici, e un battellino, con dieci posti, adatto a passare attraverso i frangenti. Questa era la capacità di trasporto delle imbarcazioni.Ci sono stati dei momenti di tempo cattivo e dei venti di prua, ma nel complesso, per sessanta giorni, abbiamo fatto un viaggio ragionevolmente buono. Ma proprio allora ho cominciato ad annotare sul diario di bordo e nel giornale di navigazione la presenza di una straordinaria e insolita quantità di ghiaccio intorno a noi e, malgrado questo, una oscurità incredibile.
Per cinque giorni e mezzo è sembrato inutile e senza vantaggio alterare la rotta per trovarci in una zona con meno ghiaccio. Ho cercato di avanzare verso sud , ma continuavamo a esserne circondati. Una volta la signora Atherfield, dopo essere rimasta per qualche tempo insieme a me sul ponte e aver osservato sbigottita gli iceberg, ha bisbigliato: “Capitano Ravender, sembra che tutta la terra si sia trasformata in ghiaccio e che si sia frantumata!” “Non ho dubbi che sembri così ai vostri occhi inesperti!” le ho risposto dorridendo, ma dentro di me ero della sua stessa opinione. Non avevo mai visto prima neanche la ventesima parte di tutto quel ghiaccio.
Tuttavia, alle due del pomeriggio del sesto giorno, il sessantaseiesimo dalla partenza, John Steadiman ha gridato dalla cima dell’albero che il mare era sgombro. Poco prima delle quattro del pomeriggio, una forte brezza ha cominciato a soffiare da poppa e al tramonto eravamo in mare aperto. La brezza si è quindi trasformata in un mezzo vento di burrasca e la Golden Mary, essendo una nave veloce, ha filato tutta la notte con il vento in poppa.
 Mi sembrava impossibile che il buio potesse essere più fitto di quel che era, a meno che il sole, la luna e le stelle fossero caduti dal cielo e fosse arrivata la fine dei tempi. Eppure quella sembrava luce rispetto alle tenebre in cui eravamo adesso. L’oscurità era così profonda che, a fissarla, dava un senso di dolore e di oppressione. Era come guardare, senza un raggio di luce, dentro una spessa benda nera posta davanti agli occhi ma senza toccarli. Ho raddoppiato i turni di guardia e John e io siamo rimasti vicini, a prua, per tutta la notte. Se stava in silenzio, anche se sapevo che c’era, non ero certo senza allungare un braccio per toccarlo, che non fosse sceso sottocoperta e fosse caduto addormentato. Entrambi stavamo attenti a quello che si poteva sentire più che a quello che si poteva vedere.
Mi sembrava impossibile che il buio potesse essere più fitto di quel che era, a meno che il sole, la luna e le stelle fossero caduti dal cielo e fosse arrivata la fine dei tempi. Eppure quella sembrava luce rispetto alle tenebre in cui eravamo adesso. L’oscurità era così profonda che, a fissarla, dava un senso di dolore e di oppressione. Era come guardare, senza un raggio di luce, dentro una spessa benda nera posta davanti agli occhi ma senza toccarli. Ho raddoppiato i turni di guardia e John e io siamo rimasti vicini, a prua, per tutta la notte. Se stava in silenzio, anche se sapevo che c’era, non ero certo senza allungare un braccio per toccarlo, che non fosse sceso sottocoperta e fosse caduto addormentato. Entrambi stavamo attenti a quello che si poteva sentire più che a quello che si poteva vedere. Il giorno seguente ho notato che il livello del mercurio nel barometro, che aveva continuato a salire da quando avevamo superato i ghiacci, era rimasto stabile. Avevo sempre fatto delle osservazioni accurate, interrotte per non più di un giorno o due, e avevo sempre preso il punto. Ho segnato la posizione del sole a mezzogiorno e ho rilevato che eravamo a 58° di latitudine sud e a 60° di longitudine ovest, al largo di New South Shetland, nei pressi di Capo Horn. Era il nostro sessantasettesimo giorno di navigazione. La posizione è stata calcolata con cura. La nave faceva il suo dovere in modo ammirevole, a bordo andava tutto bene, i marinai erano esperti, efficienti e sereni, per quanto era possibile.
 La notte successiva, buia come la precedente, era l’ottava che passavo in coperta. Durante il giorno non avevo neanche fatto un sonnellino, ero sempre stato vicino al timoniere, quando non direttamente al timone, mentre avanzavamo in mezzo ai ghiacci. Solo chi ha provato la difficoltà e la sofferenza di tenere le palpebre aperte in simili tenebre, può comprendere. L’oscurità colpisce e acceca, le immagini e i lampi formatisi nei globi danno l’impressione che essi siano usciti dalle orbite, intenti a guardarti dall’esterno. Subito dopo mezzanotte, John Steadiman, che avevo convinto a riposarsi durante il giorno e che quindi era vigile e pieno di forze, mi ha detto: “Capitano Ravender, vi supplico di scendere sottocoperta. Non vi reggete più in piedi e la vostra voce è debole. Scendete e riposatevi. Vi chiamerò, se un blocco di ghiaccio ci urta.” “D’accordo, John – gli ho risposto – ma aspettiamo fino all’una, quando c’è il cambio della guardia, prima di decidere.” Alla luce di un faro di bordo, che avevo chiesto di alzare verso l’alto, ho visto che l’orologio indicava venti minuti dopo la mezzanotte.
La notte successiva, buia come la precedente, era l’ottava che passavo in coperta. Durante il giorno non avevo neanche fatto un sonnellino, ero sempre stato vicino al timoniere, quando non direttamente al timone, mentre avanzavamo in mezzo ai ghiacci. Solo chi ha provato la difficoltà e la sofferenza di tenere le palpebre aperte in simili tenebre, può comprendere. L’oscurità colpisce e acceca, le immagini e i lampi formatisi nei globi danno l’impressione che essi siano usciti dalle orbite, intenti a guardarti dall’esterno. Subito dopo mezzanotte, John Steadiman, che avevo convinto a riposarsi durante il giorno e che quindi era vigile e pieno di forze, mi ha detto: “Capitano Ravender, vi supplico di scendere sottocoperta. Non vi reggete più in piedi e la vostra voce è debole. Scendete e riposatevi. Vi chiamerò, se un blocco di ghiaccio ci urta.” “D’accordo, John – gli ho risposto – ma aspettiamo fino all’una, quando c’è il cambio della guardia, prima di decidere.” Alla luce di un faro di bordo, che avevo chiesto di alzare verso l’alto, ho visto che l’orologio indicava venti minuti dopo la mezzanotte.All’una meno cinque minuti, John ha gridato al ragazzo di alzare di nuovo la luce e, quando gli ho detto che ora fosse, mi ha nuovamente supplicato e pregato di andare sottocoperta.
“Capitano Ravender – mi ha detto – tutto procede bene, non possiamo permetterci che siate poi costretto a restare letto nemmeno per un’ora, perciò vi chiedo rispettosamente e sinceramente di scendere sottocoperta.” Alla fine ho accettato, con l’accordo che, se non fossi risalito per conto mio dopo tre ore, avrei dovuto essere chiamato. Dopo aver stabilito questo ho lasciato John al comando. Ma l’ho fatto venire vicino a me ancora una volta per chiedergli una cosa. Avevo guardato il barometro e avevo visto che il mercurio era perfettamente stabile, così sono risalito per gettare un ultimo sguardo - se si può usare questo termine riferito a un’oscurità del genere – e ho pensato che le onde affrontate e tagliate in due dalla Golden Mary producevano un rumore insolito, una risonanza sorda. Stavo in piedi sul cassero di poppa, sul lato destro, e ho chiamato John accanto a me perché ascoltasse. Lo ha fatto con la massima attenzione. Poi, girandosi verso di me, mi ha detto: “Datemi retta, capitano Ravender, voi siete stato troppo a lungo senza riposarvi e la differenza sta solo nel modo in cui il vostro udito alterato percepisce il rumore.” Ho pensato che avesse ragione e lo penso tuttora, anche se non ne avrò mai la certezza.
 Quando ho lasciato John Steadiman al comando la nave procedeva a grande velocità fra le onde. Il vento soffiava a favore, le vele, ridotte, erano gonfie e prendevano il vento in modo propizio alla rotta. Era tutto a posto, non c’era nulla di cui lamentarsi. Il mare era mosso, ma non troppo agitato.
Quando ho lasciato John Steadiman al comando la nave procedeva a grande velocità fra le onde. Il vento soffiava a favore, le vele, ridotte, erano gonfie e prendevano il vento in modo propizio alla rotta. Era tutto a posto, non c’era nulla di cui lamentarsi. Il mare era mosso, ma non troppo agitato.Mi sono ritirato per riposare ‘in piedi’, come diciamo noi marinai, ovvero con indosso i vestiti e il giaccone. Ho tolto solo le scarpe, perché i miei piedi, dopo la lunga permanenza in coperta, erano gonfi. Nella cabina c’era una piccola lampada accesa. L’ho guardata prima di chiudere gli occhi e ho pensato che ero così stanco e affaticato dal buio, che avrei potuto addormentarmi anche in mezzo a un milione di lampioni a gas accesi. È stato l’ultimo pensiero che ho avuto prima di prendere sonno, anche se la sensazione che non sarei riuscito a dormire non mi aveva abbandonato del tutto.
Ho sognato di essere tornato a Penrith e di stare girando attorno alla chiesa, anche se questa aveva cambiato forma da quando l’avevo vista l’ultima volta e aveva una strana fenditura fino alla metà del campanile. Non so perché volessi girarle attorno ma ero ansioso di farlo, perché, nel sogno, la mia vita dipendeva da quello. Tuttavia, malgrado gli sforzi, non ci riuscivo. Stavo ancora provandoci quando vi ho sbattuto contro con un gran colpo e sono stato sbalzato fuori dalla cuccetta, contro la fiancata della nave.
Tuttavia, più del legno duro mi hanno colpito le urla e un terribile grido, in mezzo ai rumori stridenti, agli schianti e all’irrompere tumultuoso dell’acqua e al suo infrangersi, tutti suoni che conoscevo fin troppo bene. Sono salito in coperta, anche se non era una cosa semplice, perché la nave sbandava spaventosamente e scarrocciava in modo furibondo.
Non riuscivo a vedere gli uomini mentre avanzavo, ma sentivo che stavano ammainando le vele, in modo disordinato. Avevo in mano il megafono e, mentre li dirigevo e li incoraggiavo, ho chiamato John Steadiman e il secondo ufficiale William Rames. Hanno risposto entrambi in modo chiaro e fermo. Era sempre stata mia abitudine addestrare l’equipaggio, nel caso di eventi imprevisti e drammatici, a prendere posto in un punto prestabilito della nave e aspettare i miei ordini. Dopo la loro risposta in mezzo ai rumori dell’imbarcazione e del mare, fra le urla dei passeggeri sottocoperta, c’è stata una pausa di silenzio.
“Siete pronto, Rames?”
“Sìssignore!”
“Dunque, accendete la lampada, per amor di Dio!”
 In un attimo, lui e un altro hanno acceso le torce e la nave e tutto ciò che era a bordo sono stati avvolti da un alone di luce, sotto alla grande cupola nera.
In un attimo, lui e un altro hanno acceso le torce e la nave e tutto ciò che era a bordo sono stati avvolti da un alone di luce, sotto alla grande cupola nera.La luce arrivava così in alto da permettermi di vedere per intero l’enorme iceberg contro cui avevamo sbattuto, spaccato a metà proprio come la chiesa di Penrith del mio sogno. Nello stesso momento vedevo i marinai di guardia, a cui era stato appena dato il cambio, che si riunivano qua e là sul ponte; vedevo la signora Atherfield e la signorina Coleshaw, gettate l’una contro l’altra dal movimento della nave, dibattersi e lottare per portare su la bambina; vedevo gli alberi distrutti dall’urto e dallo sbandamento; vedevo la falla sul fianco dell’imbarcazione che si estendeva per metà della sua lunghezza, con il rivestimento di legno e le ordinate che spuntavano fuori; vedevo il cutter ridotto a pezzi e inutilizzabile e gli sguardi di tutti rivolti verso di me. Ma se anche fossero stati diecimila gli occhi fissi su di me, avrei distinto le espressioni di ognuno. E tutto questo in un solo momento. Ma che momento!
I marinai, dopo avermi guardato fisso, da quegli individui in gamba e responsabili che erano sono scivolati verso i posti che erano stati loro assegnati. Se la nave non si fosse raddrizzata, avrebbero potuto fare ben poco se non morire – non che morire al proprio posto sia poco per un uomo – e non avrebbero potuto far nulla per salvare se stessi e i passeggeri. Fortunatamente, la violenza con cui eravamo andati a sbattere contro l’iceberg, come se esso fosse stato la nostra destinazione e non la nostra distruzione, aveva squarciato la nave ma l’aveva anche fatta staccare e raddrizzata. Non c’era bisogno che il carpentiere mi dicesse che essa imbarcava acqua e che stava affondando, lo vedevo e lo sentivo da me. Ho detto a Rames di mettere in acqua la scialuppa e il battello e ho distribuito gli incarichi a tutti. Nessuno si è tirato indietro e nessuno ha cercato di passare davanti agli altri. Ho bisbigliato a John Steadiman: “John, io rimango qui accanto alla passerella, fino a quando non saranno tutti in salvo. Voi avrete il secondo posto di rispetto e sarete il penultimo a lasciare la nave. Raggruppate i passeggeri, disponeteli in fila dietro di me e sistemate nelle barche tutte le provviste e l’acqua che riuscite a far stare. Guardate laggiù davanti, John, vedete che non c’è un momento da perdere. “
I miei generosi compagni hanno ammainato le barche lungo la fiancata, con tutto l’ordine possibile con il mare agitato e, quando sono state pronte, due o tre uomini che le tenevano in equilibrio mentre salivano e scendevano con il movimento delle onde, si sono rivolti a me e mi hanno gridato: “Capitano, se qualcosa per noi va storto e voi vi salvate, ricordatevi che siamo stati al vostro fianco!”.
“Ragazzi miei, se Dio vuole voi sarete ancora con me quando raggiungeremo terra! – ho risposto – tenete duro e siate gentili con le signore.”
Le donne si comportavano in modo esemplare. Benchè tremanti, erano tranquille e perfettamente controllate.
“Datemi un bacio, capitano Ravender - mi ha detto la signora Asherfield - e che Dio vi benedica, brav’uomo.”
“Signora, queste parole per me sono meglio di una scialuppa!” le ho risposto.
Ho tenuto in braccio la sua bambina finchè non è scesa nella barca, poi le ho dato un bacio e gliel’ho porta. Quindi, rivolgendomi alle altre persone, ho detto: “Miei cari, il vostro mezzo di trasporto è al completo. Io non vengo con voi, devo rimanere qui ancora un po’. Allontanatevi dalla nave e prendete il largo!”
Era la scialuppa lunga. A bordo c’era anche il vecchio signor Rarx, il solo che si fosse comportato male da quando la nave era andata a sbattere. Non si possono biasimare quelli che erano agitati, ma lui, con le sue lamentele, creava un tale trambusto a bordo da essere pericoloso per gli altri, dato che la disperazione e l’egoismo sono contagiosi. Chiedeva a gran voce che non lo separassero dalla bambina, diceva di non vederla, mentre loro dovevano stare insieme. Ha persino provato a strapparmela dalle braccia, per tenerla lui.
“Signor Rarx – gli ho detto – in tasca ho una pistola carica e, se non vi allontanate immediatamente dal barcarizzo e non vi calmate, vi pianto una pallottola nel cuore, se ne avete uno.”
“Capitano Ravender, non vorrete commettere un omicidio!” mi ha risposto.
“Signore – gli ho detto – non farei morire quarantaquattro persone per compiacere voi, ma ucciderei voi per salvare loro.” A queste parole si è calmato e si è rassegnato ad aspettare, rabbrividendo, fino a quando non l’ho chiamato per farlo scendere nell’imbarcazione. Poi, la scialuppa si è allontanata, il battellino si è riempito in fretta e a bordo della Golden Mary siamo rimasti solo John Steadiman, John Mullion, il marinaio che aveva sempre tenuto accese le torce con grande calma, e io. Ho sollecitato i due a salire sul battellino e a staccarsi, poi ho atteso con cuore grato che la scialuppa tornasse a prendermi, se era possibile. Ho guardato l’orologio alla luce della torcia e ho visto che erano le due e dieci. I marinai non avevano perso tempo. Appena sono stati abbastanza vicini, sono saltato a bordo, gridando loro: “Forza, ragazzi! Sta affondando!” Quando si è creato il vortice in cui la nave è sprofondata, noi eravamo a poca distanza dal risucchio più forte, nel quale l’abbiamo vista colare a picco di prua, alla luce della torcia che John Mullion teneva accesa a bordo della scialuppa.
La bambina si è messa a piangere disperatamente: “Oh la cara Golden Mary! Oh guardatela! Salvatela! Salvate la povera Golden Mary! Poi la torcia si è spenta e la nera cappa della notte ci ha avvolti.
Penso che difficilmente ci saremmo sentiti più soli e abbandonati di come ci sentivamo in quell’oceano, nella cui profondità era scomparsa la bella nave su cui dormivamo tranquilli fino a mezz’ora prima, se dalla cima di un monte, avessimo visto sprofondare il mondo attorno a noi. C’era un terribile silenzio nella scialuppa, i rematori e il timoniere sembravano paralizzati e riuscivano a malapena a tenere la barca in posizione. Ho detto loro: “Ringraziamo Dio per la nostra salvezza!” Un coro di voci, compresa quella della bambina, ha risposto: “Ringraziamo Dio!” Poi ho recitato il Padre Nostro e tutti i marinai si sono uniti a me in un mormorio solenne. Ho aggiunto: “Coraggio, ragazzi! State di buon animo!” e ho sentito che la barca era di nuovo governata come si doveva.
La torcia sul battellino ci indicava la sua posizione e ci permetteva di dirigerci verso di esso, accostandoci quanto più il nostro coraggio lo consentiva. Ho sempre tenuto un paio di rotoli di corda sulle barche che comandavo e quindi i marinai avevano delle cime a portata di mano. Ci siamo adoprati, con grande fatica, per avvicinarci e legarci, nonché per dividere le torce, che, però, non funzionavano più perché erano finite in acqua. Siamo rimasti vicini per tutta la notte, a volte sciogliendo la cima, a volte tesandola. Abbiamo atteso, stanchi, che spuntasse l’alba. Tuttavia, essa ha impiegato così tanto ad arrivare che il signor Rarx ha esclamato: “Il mondo sta per finire e il sole non sorgerà mai più!”
 Quando il cielo si è schiarito, ho visto che eravamo tutti accalcati dalla stessa parte dell’imbarcazione, in condizioni pietose. Eravamo in trentuno, sei in più di quelli che la barca poteva trasportare e per questo essa imbarcava acqua. Nel battellino erano in quattordici, quattro in più del massimo consentito. La prima cosa che ho fatto è stata di mettermi al timone, che da quel momento non ho più lasciato, e di far sedere vicino a me la signora Atherfield con la sua bambina e la signorina Coleshaw. Nello stesso tempo, ho sistemato il signor Rarx a prua, il più lontano possibile da noi. Ho chiamato vicino a me alcuni degli uomini migliori, in modo che prendessero il timone nel caso in cui io fossi crollato.
Quando il cielo si è schiarito, ho visto che eravamo tutti accalcati dalla stessa parte dell’imbarcazione, in condizioni pietose. Eravamo in trentuno, sei in più di quelli che la barca poteva trasportare e per questo essa imbarcava acqua. Nel battellino erano in quattordici, quattro in più del massimo consentito. La prima cosa che ho fatto è stata di mettermi al timone, che da quel momento non ho più lasciato, e di far sedere vicino a me la signora Atherfield con la sua bambina e la signorina Coleshaw. Nello stesso tempo, ho sistemato il signor Rarx a prua, il più lontano possibile da noi. Ho chiamato vicino a me alcuni degli uomini migliori, in modo che prendessero il timone nel caso in cui io fossi crollato. Anche se il cielo era minaccioso e pieno di nuvole, il mare era calmo e abbiamo potuto parlare con le persone sull’altra barca, capire quante provviste avessero e verificare quante ne avevamo noi. In tasca avevo una bussola, un piccolo cannocchiale allungabile, una pistola a due canne, un coltello, una scatola con l’acciarino e la pietra focaia e dei fiammiferi. La maggior parte dei miei uomini aveva un coltello, alcuni avevano un po’ di tabacco, altri anche una pipa. Avevamo anche una tazza e un cucchiaio di metallo. Come provviste avevamo due sacchi di gallette, un pezzo di manzo crudo, un pezzo di maiale, un sacchetto di caffè tostato ma non macinato - probabilmente era stato collocato lì per sbaglio - due botti d’acqua e un barilotto di rum. Sul battellino c’era più rum che da noi e meno persone per berlo, perciò ce ne è stato dato un quarto di gallone. In cambio, noi abbiamo ceduto tre manciate di caffè, avvolte in un brandello di fazzoletto. Loro hanno detto di avere anche un sacchetto di gallette, un pezzo di manzo, un piccolo barile d’acqua, una scatola di limoni e un formaggio olandese. C’è voluto del tempo per fare questi scambi, che comportavano dei pericoli per tutte e due le imbarcazioni.  Il mare si era fatto agitato e rendeva rischiose le manovre di avvicinamento. Nell’involucro del caffè ho messo un foglio strappato dal mio taccuino con un messaggio per John Steadiman, che aveva con sé una bussola. C’era l’indicazione della rotta che intendevo seguire, nella speranza di trovare la terraferma o di essere salvati da qualche nave di passaggio. La speranza c’era, ma la fiducia che una di queste circostanze si avverasse era poca. Gli ho anche gridato, in modo che tutti sentissero, che le due barche si sarebbero salvate o sarebbero perite insieme, ma che se le intemperie ci avessero separati, loro avrebbero avuto le nostre preghiere e benedizioni come noi speravamo di avere le loro. Poi gli abbiamo lanciato tre grida di incoraggiamento, che loro hanno ricambiato e ho visto i marinai chinare il capo, in entrambe le barche, mentre le loro schiene si curvavano di nuovo sui remi.
Il mare si era fatto agitato e rendeva rischiose le manovre di avvicinamento. Nell’involucro del caffè ho messo un foglio strappato dal mio taccuino con un messaggio per John Steadiman, che aveva con sé una bussola. C’era l’indicazione della rotta che intendevo seguire, nella speranza di trovare la terraferma o di essere salvati da qualche nave di passaggio. La speranza c’era, ma la fiducia che una di queste circostanze si avverasse era poca. Gli ho anche gridato, in modo che tutti sentissero, che le due barche si sarebbero salvate o sarebbero perite insieme, ma che se le intemperie ci avessero separati, loro avrebbero avuto le nostre preghiere e benedizioni come noi speravamo di avere le loro. Poi gli abbiamo lanciato tre grida di incoraggiamento, che loro hanno ricambiato e ho visto i marinai chinare il capo, in entrambe le barche, mentre le loro schiene si curvavano di nuovo sui remi.
 Il mare si era fatto agitato e rendeva rischiose le manovre di avvicinamento. Nell’involucro del caffè ho messo un foglio strappato dal mio taccuino con un messaggio per John Steadiman, che aveva con sé una bussola. C’era l’indicazione della rotta che intendevo seguire, nella speranza di trovare la terraferma o di essere salvati da qualche nave di passaggio. La speranza c’era, ma la fiducia che una di queste circostanze si avverasse era poca. Gli ho anche gridato, in modo che tutti sentissero, che le due barche si sarebbero salvate o sarebbero perite insieme, ma che se le intemperie ci avessero separati, loro avrebbero avuto le nostre preghiere e benedizioni come noi speravamo di avere le loro. Poi gli abbiamo lanciato tre grida di incoraggiamento, che loro hanno ricambiato e ho visto i marinai chinare il capo, in entrambe le barche, mentre le loro schiene si curvavano di nuovo sui remi.
Il mare si era fatto agitato e rendeva rischiose le manovre di avvicinamento. Nell’involucro del caffè ho messo un foglio strappato dal mio taccuino con un messaggio per John Steadiman, che aveva con sé una bussola. C’era l’indicazione della rotta che intendevo seguire, nella speranza di trovare la terraferma o di essere salvati da qualche nave di passaggio. La speranza c’era, ma la fiducia che una di queste circostanze si avverasse era poca. Gli ho anche gridato, in modo che tutti sentissero, che le due barche si sarebbero salvate o sarebbero perite insieme, ma che se le intemperie ci avessero separati, loro avrebbero avuto le nostre preghiere e benedizioni come noi speravamo di avere le loro. Poi gli abbiamo lanciato tre grida di incoraggiamento, che loro hanno ricambiato e ho visto i marinai chinare il capo, in entrambe le barche, mentre le loro schiene si curvavano di nuovo sui remi. Questi accordi ci avevano tenuti occupati, anche se, come ho accennato nell’ultima frase, una volta conclusi ci è piombata addosso una grande tristezza. Ho informato brevemente i passeggeri sulla scarsità delle provviste di cui disponevamo e da cui dipendevano le nostre vite – se il profondo abisso le avesse risparmiate - e della necessità di disporne con la massima frugalità. Hanno risposto tutti che si sarebbero attenuti alle disposizioni che io avessi ritenuto di dare. Con alcune lamiere di ferro e una cordicella abbiamo fabbricato due bilance. Come pesi ho deciso di utilizzare alcuni grossi bottoni che, ho calcolato, dovevano misurare un po’ più di due once. Questa era la quantità di cibo solido servita a colazione, insieme a un chicco di caffè, che diventava mezzo quando il tempo era bello. Non avevamo altro, all’infuori di mezza pinta d’acqua al giorno.
 A volte, quando avevamo freddo ed eravamo indeboliti, veniva servito un cucchiaino di rum. So che il rum è generalmente considerato un veleno, ma so anche che, nel nostro caso e in altri simili, esso rappresenta un ristoro e un sostegno. E non ho dubbi che esso abbia salvato la vita a più della metà di noi. Ho detto che avevamo a disposizione una mezza pinta d’acqua al giorno, ma in certi giorni ne avevamo di meno, mentre nei giorni di pioggia ne avevamo di più, perché la raccoglievamo con un telo.
A volte, quando avevamo freddo ed eravamo indeboliti, veniva servito un cucchiaino di rum. So che il rum è generalmente considerato un veleno, ma so anche che, nel nostro caso e in altri simili, esso rappresenta un ristoro e un sostegno. E non ho dubbi che esso abbia salvato la vita a più della metà di noi. Ho detto che avevamo a disposizione una mezza pinta d’acqua al giorno, ma in certi giorni ne avevamo di meno, mentre nei giorni di pioggia ne avevamo di più, perché la raccoglievamo con un telo. Così in quel periodo, in quella zona burrascosa, noi naufraghi andavamo su e giù seguendo il movimento delle onde. Non voglio descrivere le circostanze della nostra dolorosa condizione, dato che è già stato fatto in altri resoconti, meglio di come potrei farlo io. Dico solo che, giorno dopo giorno e notte dopo notte, prendevamo il mare di poppa per evitare che la scialuppa imbarcasse acqua, che una parte di noi continuava a sgottare e che i nostri cappelli e berretti usati, in mancanza d’altro, come recipienti, erano mal ridotti e rammendati più volte. Alcuni di noi stavano distesi sul fondo della barca, mentre gli altri remavano e ben presto, sotto agli stracci, eravamo tutti coperti di bolle e di vesciche.
L’altra barca era fonte per tutti noi di una tale ansiosa apprensione che mi chiedevo se, una volta che ci fossimo salvati, avremmo mai potuto diventare indifferenti al destino degli altri sopravvissuti. Quando il tempo lo permetteva, cosa che non succedeva spesso, ci legavamo con la cima di traino e Dio solo sa come riuscivamo a mantenere lo stesso orizzonte, ma, grazie alla sua misericordia, questo ci è stato consentito. Non dimenticherò mai lo sguardo con cui, quando spuntava l’alba, guardavamo fisso le acque tempestose, per scorgere l’altra imbarcazione. Quando abbiamo perso di vista i nostri compagni per settantadue ore di seguito, abbiamo temuto che fossero affondati e loro hanno pensato lo stesso di noi. La gioia di tutti quando siamo tornati a vederci aveva in sé qualcosa di divino: ci siamo dimenticati delle nostre sofferenze e, per l’affetto che ci legava, piangevamo di felicità.